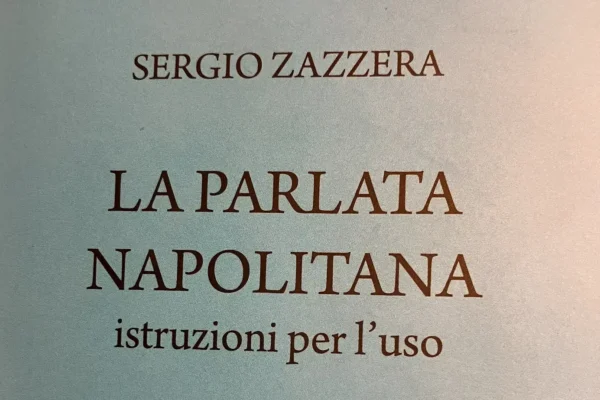Che Giovanni Boccaccio abbia vissuto a Napoli i suoi anni giovanili è noto. Figlio di un socio della potente Banca dei Bardi (quella che finanziò i nostri re angioini), venne qui quattordicenne e se ne andò ventisettenne.
Con questa appartenenza e queste conoscenze, a Napoli Boccaccio poté frequentare gli ambienti aristocratici e colti del bel mondo che ruotava attorno alla corte angioina. E certo la brigata dei dieci giovani amici che avrebbero raccontato le 100 novelle del Decameron dovette avere il suo principale modello proprio nella gioventù partenopea nobile ed altoborghese, quell’ambiente elegante e colto, e insieme cameratesco e allegro, che Giovanni rimpianse molto quando dovette tornare a Firenze.
 Tornò infatti a Firenze nel 1340, ed è di quell’anno, o forse dell’anno prima, la lettera che scrisse al suo amico Francesco de’ Bardi, che si trovava in quel periodo a Gaeta. Il cognome di quest’ultimo ce lo presenta come giovane rampollo della ricca famiglia di banchieri di cui sopra.
Tornò infatti a Firenze nel 1340, ed è di quell’anno, o forse dell’anno prima, la lettera che scrisse al suo amico Francesco de’ Bardi, che si trovava in quel periodo a Gaeta. Il cognome di quest’ultimo ce lo presenta come giovane rampollo della ricca famiglia di banchieri di cui sopra.
Dunque né lui né il destinatario erano napoletani. Eppure Giovanni volle scrivere proprio in quel “volgare”, inconsapevole di anticipare di quasi due secoli la nascita di una letteratura “riflessa” in napoletano. E lo fece per divertimento.
Lo dice lui stesso, in un preambolo in fiorentino, dove afferma: “per diporto di noi medesimi ti scriviamo” (cioè “ti scrivo per divertirci un po’).
Il napoletano adoperato nella lettera (che non trascriviamo qui essendo facilmente reperibile anche su internet) è sicuramente, nella sostanza, quello usato nel parlato dell’epoca: mammana per “levatrice”, zitella per “giovane donna non sposata” (non “donna nubile attempata” come per noi), per non parlare dei doppi imperativi, tipicamente nostrani, ba’ spìcciati e ba’ iòcati. Esso però presenta alcune “irregolarità”, come la forma fratiello per frate, dittonghi impropri, come biello per bello, puorpo per purpo e cose simili, che evidentemente lo scrittore fiorentino sentiva come caratteristiche tipiche della parlata napoletana, incorrendo più volte in esagerazioni e ipercorrettismi.
Il messaggio contenuto nella lettera sembrerebbe di scarso interesse, se non fosse per il finale.
Giovanni annuncia al suo amico Francesco che una donna di loro conoscenza, tale Machinta, ha da poco partorito un bel maschietto, e che sia la levatrice, sia il parroco (“lo patino”) dicono che è somigliantissimo al padre, e la puerpera ha ricevuto la visita di molte belle donne, di quelle che Giovanni e Francesco conoscono bene, che sono della loro “chiazza” (secondo alcuni si allude alla “piazza” o “seggio” di Nido, frequentato dall’autore e dai suoi amici, e Machinta sarebbe una prostituta, ma dal testo questo non si evince con certezza).
Questa ed altre allusioni maliziose si leggono qua e là nel testo, anche se non sono interpretabili facilmente, dato che fanno riferimento a persone ed eventi noti solo nell’ambiente dei due interlocutori.
 Lo scrittore si dilunga per un bel po’ a descrivere le numerose persone presenti alla festa del battesimo, descrivendo persino il “ciprese” (una “sorta di cappotto di velluto foderato di pelle”, De Blasi) in cui era avvolto il bambino (e di cui dice “no saccio se te s’aricorda qualisso boglio dicere eo”, cioè “non so se ti ricordi quale voglio dire io”: doveva essere forse un dono di Francesco alla donna) e soffermandosi compiaciuto sulle donne e sul loro look.
Lo scrittore si dilunga per un bel po’ a descrivere le numerose persone presenti alla festa del battesimo, descrivendo persino il “ciprese” (una “sorta di cappotto di velluto foderato di pelle”, De Blasi) in cui era avvolto il bambino (e di cui dice “no saccio se te s’aricorda qualisso boglio dicere eo”, cioè “non so se ti ricordi quale voglio dire io”: doveva essere forse un dono di Francesco alla donna) e soffermandosi compiaciuto sulle donne e sul loro look.
Alla fine, inaspettatamente, lo scrittore esce in questa frase:
“che bene àiati ’sta tia minchia, che ne trasìo a Machinti, che n’àbemo sì bello zitiello!” (“che stia bene questa tua “minchia”, che entrò in Machinti, sicché ne avemmo un così bel bambino!”).
Dunque il figlio era in realtà di Francesco!
Alla sorpresa se ne aggiunge per noi un’altra di tipo linguistico: Boccaccio usa qui il termine siciliano “minchia”. Evidentemente su certi argomenti i linguaggi si mescolavano, allora come adesso!
Insomma, questa nobile, elegante e colta brigata di amici non si tirava certo indietro di fronte alla possibilità di conoscere belle donne e di fare “caccia” spinta!
La lettera non aggiunge molto invero a quanto già sappiamo di Boccaccio, che a Napoli dovette frequentare anche gli ambienti “bassi”, se ricordiamo l’ambientazione nei bassifondi di Napoli in una novella come “Andreuccio da Perugia”.
Dal punto di vista linguistico-letterario, la sua presenza e la sua attività artistica (scrisse a Napoli almeno tre poemetti e un romanzo in prosa) contribuirono senza dubbio alla “toscanizzazione” della cultura napoletana.
Tornando alla lettera, nonostante la punta maliziosa che in essa si avverte, vi scorgiamo senz’altro quella concezione naturalistica e serena dell’amore di cui è intriso non solo il Decameron e che gli fece, tra l’altro, sublimare l’incontro (chissà quanto reale e quanto simbolico) con Maria d’Aquino, la figlia naturale del re Roberto, nella chiesa di San Lorenzo.
Altro motivo di interesse della lettera, oltre a quello linguistico, è uno sdoppiamento della personalità del mittente, un gioco letterario che si ritrova nella letteratura colta “comico-realistica”, che imita modi popolareschi. Egli infatti si firma Jannetta di Parisse (Giannetto di Parigi: il Boccaccio costruì di sé il mito letterario di giovane rampollo reale francese, figlio illegittimo di una donna della famiglia dei Capetingi, così come mito letterario può essere quello di Fiammetta) ma nel corso della lettera allude a un “abate Ja’ Boccaccio”, ostinatamente dedito agli studi anziché alla bella vita come vorrebbero gli amici della brigata.