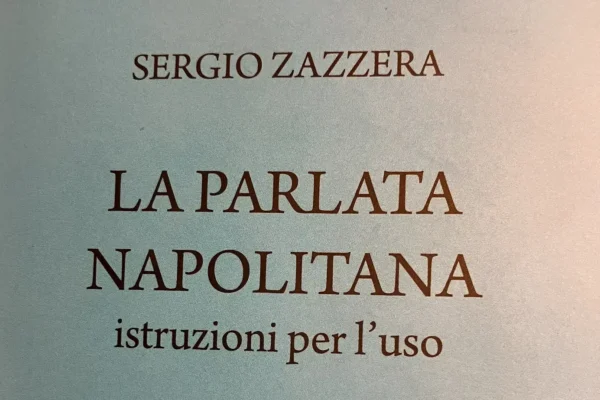“La poesia vernacola napoletana […] si sviluppò ignorando di avere avuto in Stazio un […] precursore”.
Così si legge nella Letteratura latina di E. Paratore.
Faceva di mestiere il poeta.Questo precursore si chiamava Publio Papinio Stazio, nato a Napoli, ivi cresciuto e poi stabilitosi a Roma, quindi tornato nella sua città d’origine per trascorrervi la vecchiaia.
Di mestiere, sì, perché nel I secolo dopo Cristo quello del poeta era proprio un mestiere, apprezzato nel bel mondo dei ricchi e dei nobili in quanto, non essendoci ancora la ricca offerta odierna di talk show televisivi (per mancanza appunto della televisione), loro si rilassavano così: nelle apposite sale di recitazione, oppure nei lunghi dopocena con ospiti, tra un balletto e un po’ di conversazione, ascoltavano qualcuno che recitava i suoi versi con ritmo ed espressività.
E spesso quei versi erano scritti proprio per il padrone di casa o per un suo invitato particolarmente illustre, a volte persino per l’imperatore.
Sicché un poeta, se aveva fortuna, poteva entrare in un giro di amicizie che gli dava fama (“visibilità”, si direbbe oggi) e anche soldi.

Papinio Stazio era figlio di un maestro, e forse suo padre aveva avuto per alunni i figli di persone importanti, se lui poi poté frequentare il bel mondo.
Arrivò ad essere apprezzato perfino dall’imperatore, che all’epoca era Domiziano, quello che fece costruire la via Domiziana che percorriamo ancora oggi (sia pure con varianti rispetto all’epoca, perché fu distrutta e poi ricostruita nel medioevo).
Prima, nei tempi in cui ancora si arrangiava, Stazio aveva scritto una pantomima (un libretto per una performance teatrale che prevedeva musica e recitazione) per un attore, Paride, che era talmente beneamato a corte da conquistare le grazie della moglie di Domiziano, Domizia Longina, finché l’imperatore non scoprì che quella simpatia non era solo artistica e, a quanto pare, fece morire l’attore.
Tra questi ed altri intrighi di corte si doveva trovare un poeta famoso dell’epoca, e vi si trovò infatti il nostro Stazio.
Il quale, a un certo punto della sua vita (forse verso i cinquant’anni, che per l’epoca era un’età ragguardevole) decise di tornarsene nella sua città, Napoli.
Dovette però faticare non poco per convincere la moglie Claudia a seguirlo. Perché Claudia era una di quelle donne che amavano frequentare la cosiddetta bella gente, e le sembrava di diventare una provinciale accettando di stare lontano da Roma.
Ci provò (e sembra che ci riuscì) ricorrendo a quello che sapeva far meglio, cioè alla poesia: scrisse una poesia di un centinaio di versi, nella quale, oltre ad elogiare la moglie e il loro amore, parlava in modo entusiastico di Napoli e dintorni, descrivendo la nostra città come un luogo di delizie paragonabili alla stessa Roma.
A questo punto è opportuno citare qualche verso di questa silva (si chiamavano così queste poesie), e lo faremo traducendo in napoletano moderno, certi che l’ombra di Stazio non se ne avrà a male, visto che usiamo la lingua derivata proprio dal latino che parlava anche lui con i suoi amici e parenti:
“Tu ccà ce truove tutto, ’o circo e ’o triato, / ’e juoche comm’a Roma. Haje voglia ’e fa resate, / ma sempe cu’ rispetto, e maje scustumate”.
In questo modo il poeta faceva anche un complimento ai napoletani, sempre pronti all’allegria ma mai con disprezzo degli altri.
Invece a Roma si viveva in un ambiente pieno di invidie e gelosie, di timori continui di colpi bassi e tradimenti. A Napoli no:
“nun hê ’a stà sempe all’erta pe dint’ ’e tribunale: / ccà ’a gente è ghiusta e aunesta, pure senza surdate.”
Non c’è bisogno di un’autorità che intimorisca (“i soldati”, abbiamo tradotto noi; “i fasci” di Roma imperiale, diceva l’originale) perché i napoletani sono persone giuste ed oneste.
Ma la parte più bella del testo è quella che decanta le bellezze dei dintorni di Napoli, e con cui chiudiamo, sempre nella nostra traduzione:
“Che pace int’a sti poste! Può stà senza fa niente / e niente te scumpone, nisciuno maje te sceta: / […] / E po’, che vista bella, quanta campagne arate, / quanta tempie granniuse e ricche ’e culunnate! / […] / E ce stanno ccà ttuorno spettacule ca ncantano: / Ce sta Baia cu’ ’e ssurgente d’acqua caura fumante, / e belli spiagge, e ’a rotta d’ ‘a Sibilla ce sta / e ’a muntagna ’e Miseno, ca ricorda ’e Troiane, / e ’e pergulate carreche d’uva d’ ’o monte Gauro / e Capri, ca, cu’ ’o faro, riala, comm’ ’a luna / che cammina int’a notte, splennore ê marenare / ca tornano int’ ’e puorte. E ’e mmuntagne ’e Surriento / addò cresce abbunnante n’uva nu poco asprigna / d’ ’e pergulate ’e Pollio, l’amico mio cchiù caro. / E Ischia, ditta Enaria pecché ce apprudaje Enea, / cu ll’acque ca te curano. E Stabia ch’è rinata…”.
Solo qualche piccola spiegazione per capire meglio i versi:
Miseno ricorda i Troiani perché prende il nome da Miseno, un compagno di Enea che morì in quel luogo (lo vediamo raffigurato nel bassorilievo conservato nel museo del castello a Baia)
Pollio era Pollio Felice, un amico di Stazio che aveva proprietà e vigneti a Sorrento.
Stabia era “rinata” dopo l’eruzione del Vesuvio del 79 d. C.