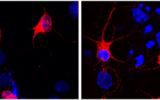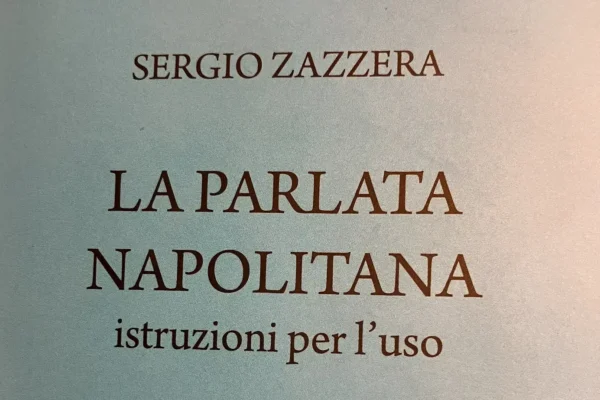Cecca se chiamma la Segnora mia,
la faccia ha tonna comme a no pallone,
ha lo colore iusto de premmone
stato no mese e cchiù a la vocciaria.
Si chiama Cecca la Donna mia, / ha la faccia tonda come un pallone, / ha il colorito proprio come il polmone / rimasto un mese e più in macelleria.
 Queste le “bellezzetudene” della donna del poeta di cui parliamo oggi, Filippo Sgruttendio, autore de La tiorba a taccone, un canzoniere in dialetto napoletano edito nel 1646.
Queste le “bellezzetudene” della donna del poeta di cui parliamo oggi, Filippo Sgruttendio, autore de La tiorba a taccone, un canzoniere in dialetto napoletano edito nel 1646.
Ma non basta: Cecca ha anche, tra l’altro, “no pede chiatto dinto a lo scarpone / che cammenanno piglia meza via”, ed è bavosa, “cchiù vavosa che non è l’anguilla”. Siamo in pieno clima culturale barocco.
Il poeta Giambattista Marino ha da tempo pubblicato, tra l’altro, la raccolta di poesie La lira. Il suo modo di poetare, che s’impone come modello in tutta Italia, è basato sul principio che il poeta deve stupire il lettore con trovate sempre più originali e intelligenti. È un modo di opporsi all’altra tendenza, quella classicista, che imita ormai sempre più stancamente Petrarca creando versi che appaiono scontati e banali alle nuove generazioni di poeti.
Di questi poeti Marino è il riconosciuto caposcuola, tanto da dar luogo a una tendenza detta appunto marinismo, i cui rappresentanti, pur di meravigliare il lettore, giungono ad eccessi davvero ridicoli, come quello di scrivere una poesia per lodare della donna amata non solo i capelli, gli occhi, il pettine con cui si acconcia la chioma etc., ma tutto, un difetto fisico come lo strabismo, le stranezze fisiche o comportamentali, e perfino i pidocchi, “fiere d’avorio” che il “bosco d’oro” dei capelli ospita in abbondanza (così in un sonetto di un marinista. Solo di sfuggita ricorderemo che l’americano D.D.T. era ancora di là da venire).
A Napoli, però, come anche in altre parti d’Italia, sì era fatta strada un’altra letteratura, quella in dialetto, di cui i nostri esempi più noti sono il Cunto de li cunte di Basile e poemi come La vaiasseide di Cortese (di cui parlammo recentemente su queste colonne).
E fu a Napoli che nacque La tiorba a taccone, di tal Felippo Sgruttendio de Scafato, pseudonimo anagrammatico di Don Giuseppe Storace D’Afflitto, uomo di lettere che in verità aveva fin allora prodotto ben poco, tanto che ancora oggi molti studiosi pensano (come aveva proposto molti anni fa il poeta Ferdinando Russo) che dietro di lui si nascondesse lo stesso Giulio Cesare Cortese.
Il titolo allude a uno strumento musicale a corde, la tiorba appunto, inventato sul finire del Cinquecento, e dunque ben più “à la page” della classica lira di Marino. Segno che l’autore intendeva porsi non solo in antagonismo con gli antiquati petrarchisti, ma anche con la stessa tendenza barocca, le cui premesse portava polemicamente alle estreme conseguenze (come vedremo fra poco). Ma segno anche di scelte ben precise, tra il popolare e il raffinato-colto, visto che la tiorba era un complicato mix tra il calascione (strumento popolare) e il più aristocratico liuto (anche nella versione dell’arciliuto, che aggiungeva un surplus di corde per i suoni bassi).
Strumento di accompagnamento, la tiorba presentava una doppia serie di corde, in quanto a quelle “canoniche” (come nel liuto) aggiungeva (come nell’arciliuto) una serie di corde dai toni bassi, poste al di sopra, e al di fuori, del manico e collegate a un prolungamento del manico stesso. Strumento complesso, dunque, che si suonava con il plettro, detto anche taccone (o perché somigliante a un tacco o come accrescitivo di “tacca”).
.jpg)
Leggere qua e là i sonetti e le canzoni di questo poema è un’esperienza esilarante e al tempo stesso interessante, specialmente nella traduzione con testo a fronte che ne offre Elvira Garbato nella sua edizione (Napoli, Magma, 2000).
La Tiorba a taccone è divisa in dieci parti, chiamate “corde”, di cui tre (la I, la V e la X) sono dedicate a un’immaginaria donna del cuore, chiamata Cecca, di cui abbiamo visto sopra le bellezze decantate dal poeta.
Anche le altre corde sono dedicate all’amore, all’amore in generale e all’amore (anche occasionale) per varie donne. Come la seconda corda, dedicata proprio alla “fenomenologia” dell’amore. Che l’amore faccia soffrire, era ed è un trito luogo comune. Ecco come lo esprime Sgruttendio:
Ammore, ch’è fetente com’a grutto,
Ammore, ch’è no tammaro, e no guitto,
st’ammàro core tanto m’ha destrutto,
che pare justo fecato soffritto.
Amore, ch’è fetente come rutto, / Amore, ch’è uno zotico ed un guitto, / l’amaro cuore tanto m’ha distrutto / che pare proprio fegato soffritto.
Non manca la tenzone fra il poeta e un altro, innamorati della stessa donna. Essi decidono di rimettere a lei stessa la scelta, ed ella sceglie l’altro, sicché il poeta, sconfitto, le rivolge questi versi a dispetto:
Già lo juditio l’hai mannato a Chiunzo.
E ghiusto faie, comme a lo zampaglione,
che non se posa maie, se no a lo strunzo.
Ormai il giudizio l’hai mandato a zonzo. / E giusto fai, proprio come il moscone / che non si posa se non sullo stronzo. (La parola “chiunzo”, con verbi come andare mandare etc., indica un luogo imprecisato o fuori mano; la traduzione “a zonzo” serve anche a tenere la rima).
Una carrellata di amanti sfortunati occupa vari sonetti della II corda: l’amante rifiutato perché povero, l’amante disperato, quello beffato, quello pezzente, e ancora il moccoloso, l’“infrancesato” (ovvero colpito dal “mal francese”), lo scorreggione (“pedetaro”). Per ognuno c’è un sonetto con tanto di trovata geniale, in forma di battuta finale o di metafora spinta, spesso a sorpresa.
Altra carrellata, stavolta di donne, occupa tutta la quarta corda: c’è la “bella tricchetraccara”, cioè “che faceva e venneva tricchitracche”, seguita dalla sguattera, dalla “tripparola, zoè che venneva trippa”, dalla tavernara, perfino dalla “jetta-cantare” (colei che va a svuotare in strada il vaso da notte); non manca la donna dagli occhi cisposi (“huocchie scazzate”), la guercia, quella con i dentoni (“sannuta”), la bavosa, la balbuziente, la gobba e così via, per un totale di ben trentadue sonetti.
Più ”intellettualistiche” sono le corde VI e VII, con sonetti nella VI e canzoni nella VII (come pure nelle ultime tre). In esse si legge a chiare lettere una critica serrata alla cultura del tempo, innanzitutto alle numerose “accademie” che pullulavano a Napoli come nel resto d’Italia, e che presentavano una dispersione culturale paragonabile a quella di oggi (ah, se Sgruttendio avesse conosciuto i nostri social, dove tutti scriviamo tutto, credendoci per un po’ grandi scrittori!…). Il poeta così prende le distanze dalla cultura del suo tempo, con allusioni e lodi dichiarate ai grandi poeti (“Addanto”, Dante, e “Cicco”, Francesco Petrarca) e con denuncia della servile condizione del letterato contemporaneo, per rivendicare un ruolo alla sua poetica, fatta di scelta dialettale e popolare.
Insomma, la Tiorba a taccone può essere ancora oggi una lettura molto istruttiva. Non facile, ma certamente gustosa.