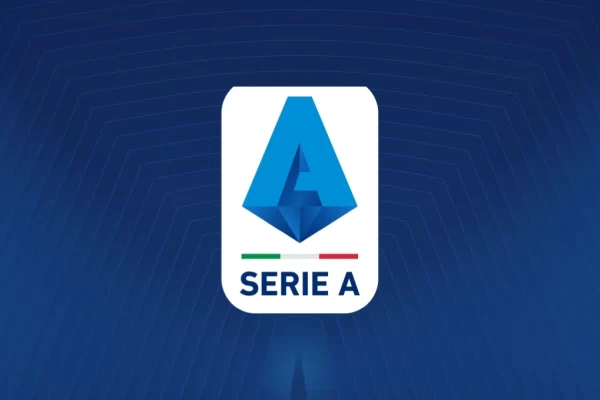Tra i tanti primati che annovera il pugilato italiano, ce n’è uno singolare: il primo e unico pugile sordomuto dalla nascita ad aver conquistato un titolo mondiale. Stiamo parlando di Mario D’Agata, nato ad Arezzo nel 1926 e morto a Firenze nel 2009. Proveniente da una famiglia numerosa, piuttosto povera, di emigranti siciliani. Per la sua condizione economica, la famiglia fu costretta ad iscrivere il proprio Mario in un istituto religioso specializzato per sordomuti a Siena. Quella irruenza, di cui sopra, che spesso era la causa delle sue squalifiche, la scoprì ben presto, difendendosi dagli altri ragazzini con pugni che già lasciavano intravvedere la sua vocazione pugilistica. Ma in quel periodo la Federazione pugilistica non si era mai trovata di fronte ad una richiesta di iscrizione al pugilato da parte di un sordomuto, mentre in molte nazioni e soprattutto in America, un pugile sordomuto era considerato alla stregua degli altri. Ci volle quasi una sommossa dei cittadini senesi per convincere la Federazione a concedere il permesso di boxare al promettente D’Agata.
 D’Agata era un peso gallo, un omino alto appena 1 metro e 57 centimetri ma con una irruenza sul ring che non temeva rivali, addolcita da una gentilezza nei pugni come se non volesse far male all’avversario di turno. Come tutti i pugili, iniziò la carriera da dilettante disputando più di 150 match. Eppure non ebbe vita facile il suo ingresso nel mondo pugilistico, per via del suo handicap, come abbiamo visto. Gli italiani si erano appena lasciato alle spalle le atrocità della guerra, e grazie anche ai successi di D’Agata incominciarono ad alzare la testa, a risollevarsi, ad avere nuovamente fiducia nella vita.
D’Agata era un peso gallo, un omino alto appena 1 metro e 57 centimetri ma con una irruenza sul ring che non temeva rivali, addolcita da una gentilezza nei pugni come se non volesse far male all’avversario di turno. Come tutti i pugili, iniziò la carriera da dilettante disputando più di 150 match. Eppure non ebbe vita facile il suo ingresso nel mondo pugilistico, per via del suo handicap, come abbiamo visto. Gli italiani si erano appena lasciato alle spalle le atrocità della guerra, e grazie anche ai successi di D’Agata incominciarono ad alzare la testa, a risollevarsi, ad avere nuovamente fiducia nella vita.
Erano gli anni in cui diventò professionista (29 giugno 1950) sotto la guida di Libero Cecchi che curava le sorti sportive anche di Carmelo Bossi, per fare un nome, conducendolo al titolo mondiale dei medi jr, e un certo Walter Annichiarico (in arte Chiari, l’attore) che non tutti sanno, da giovane, prima di intraprendere la carriera di attore, tirava di boxe, arrivando a vincere, nel 1940, i campionati lombardi giovanili. Non disputò mai gli assoluti, in quanto nel frattempo decise di dedicarsi solo al teatro, facendo una strepitosa carriera.
Nessuno credeva in quel piccolo uomo che da lì a poco sarebbe diventato campione del mondo, passato alla storia anche con il nomignolo di “piccolo Marciano” (si dice affibbiatogli dallo stesso campione italo-americano). Non aveva una tecnica eccelsa, anzi era abbastanza grezza, era un diesel spinto da una irruenza e da una bramosia che ad ogni incontro non vedeva altro che la vittoria. Non si fermava di fronte a niente il nostro D’Agata, anche quando era costretto a fare i conti col destino fuori dal ring, ma sempre reagendo alla grande, come un torello, come quella volta che venne colpito al petto da una fucilata  durante la lite tra suo padre e un debitore. La maggior parte degli addetti ai lavori pensarono che quel tragico incidente avrebbe messo la parola fine sulla sua carriera pugilistica. Invece, come in altre circostanze, si rimise in pista, riprendendo da dove aveva lasciato, cioè dalle vittorie a ripetizione. Da professionista disputò il suo primo incontro il 14 ottobre, nella sua città d’adozione, contro il più esperto Giuseppe Salardi (già professionista dal 1946), con una vittoria ai punti. Seguirono 10 vittorie consecutive fino al 22 giugno 1951, interrotte da una sconfitta ai punti contro il milanese Kid Arcelli (nome d’arte di Romolo Re), sul ring di Firenze, il 2 agosto di quell’anno.
durante la lite tra suo padre e un debitore. La maggior parte degli addetti ai lavori pensarono che quel tragico incidente avrebbe messo la parola fine sulla sua carriera pugilistica. Invece, come in altre circostanze, si rimise in pista, riprendendo da dove aveva lasciato, cioè dalle vittorie a ripetizione. Da professionista disputò il suo primo incontro il 14 ottobre, nella sua città d’adozione, contro il più esperto Giuseppe Salardi (già professionista dal 1946), con una vittoria ai punti. Seguirono 10 vittorie consecutive fino al 22 giugno 1951, interrotte da una sconfitta ai punti contro il milanese Kid Arcelli (nome d’arte di Romolo Re), sul ring di Firenze, il 2 agosto di quell’anno.
 L’Italia del dopoguerra ebbe in D’Agata il più grande pugile di quel periodo. Non ci mise molto a conquistare il titolo italiano, il 26 settembre 1953, al “Teatro Politeama Universale” di Arezzo, battendo il sardo Gianni Zuddas, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra. «Dopo aver ribadito la sua superiorità nella rivincita con Zuddas al termine di 12 round entusiasmanti, fu fermato a Tunisi dall’allora campione europeo Robert Cohen. Quella sconfitta D’Agata non la digerì mai e cosa strana l’unico nome che gli riusciva di sillabare era proprio Cohen. A Tunisi si ripaga piegando ai punti il duro Emile Chemama e poco più tardi a Milano regola il fortissimo Andrè Valignat. Dopo queste belle vittorie anche Mario decide di andare a cercare fortuna in Australia, che in quell’epoca era considerata un po’ la mecca per i nostri campioni. Li batte ai punti prima il campione australiano Bobby Sinn e poi l’americano Billy Peacock, considerato uno dei migliori gallo del mondo» (Alfredo Bruno, Addio a Mario D’Agata, in «20ut! Fuori i secondi», 4 aprile 2009).
L’Italia del dopoguerra ebbe in D’Agata il più grande pugile di quel periodo. Non ci mise molto a conquistare il titolo italiano, il 26 settembre 1953, al “Teatro Politeama Universale” di Arezzo, battendo il sardo Gianni Zuddas, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra. «Dopo aver ribadito la sua superiorità nella rivincita con Zuddas al termine di 12 round entusiasmanti, fu fermato a Tunisi dall’allora campione europeo Robert Cohen. Quella sconfitta D’Agata non la digerì mai e cosa strana l’unico nome che gli riusciva di sillabare era proprio Cohen. A Tunisi si ripaga piegando ai punti il duro Emile Chemama e poco più tardi a Milano regola il fortissimo Andrè Valignat. Dopo queste belle vittorie anche Mario decide di andare a cercare fortuna in Australia, che in quell’epoca era considerata un po’ la mecca per i nostri campioni. Li batte ai punti prima il campione australiano Bobby Sinn e poi l’americano Billy Peacock, considerato uno dei migliori gallo del mondo» (Alfredo Bruno, Addio a Mario D’Agata, in «20ut! Fuori i secondi», 4 aprile 2009).
 Il 29 ottobre 1955 arrivò anche il titolo europeo che era vacante, battendo, al “Palazzo dello Sport” di Milano, il francese André Valignat, che aveva sconfitto già l’anno prima nella sua Arezzo. Infine, si presentò l’occasione per battersi per il titolo mondiale: il 29 giugno 1956. L’avversario fu il francese Robert Cohen, di origine tunisina; la location fu lo “Stadio Olimpico” di Roma; il risultato: vittoria dell’italiano per k.o.t. al settimo round. «Un tremendo sinistro al fegato di D’Agata costrinse l’avversario al tappeto. L’arbitro lo contò fino ad 8 prima che suonasse il gong. Nella ripresa successiva Cohen non riprese i match, doveva essere quindi un abbandono, ma l’arbitro spiazzò tutti e decretò la vittoria di D’Agata per ferita» (Marco Patruno, Il campione sordomuto, in «Oltre il ponte», 7 dicembre 2016). Così il piccolo D’Agata divenne il secondo campione del mondo italiano, dopo Primo
Il 29 ottobre 1955 arrivò anche il titolo europeo che era vacante, battendo, al “Palazzo dello Sport” di Milano, il francese André Valignat, che aveva sconfitto già l’anno prima nella sua Arezzo. Infine, si presentò l’occasione per battersi per il titolo mondiale: il 29 giugno 1956. L’avversario fu il francese Robert Cohen, di origine tunisina; la location fu lo “Stadio Olimpico” di Roma; il risultato: vittoria dell’italiano per k.o.t. al settimo round. «Un tremendo sinistro al fegato di D’Agata costrinse l’avversario al tappeto. L’arbitro lo contò fino ad 8 prima che suonasse il gong. Nella ripresa successiva Cohen non riprese i match, doveva essere quindi un abbandono, ma l’arbitro spiazzò tutti e decretò la vittoria di D’Agata per ferita» (Marco Patruno, Il campione sordomuto, in «Oltre il ponte», 7 dicembre 2016). Così il piccolo D’Agata divenne il secondo campione del mondo italiano, dopo Primo  Carnera, ma il primo su terra italiana. Però il suo trono durò solo un anno, allorché l’1 aprile 1957, al “Palais des Sports” di Parigi, dovette cederlo al francese Alphonse Halimi ai punti, dopo 15 riprese che si tramutarono in una vera battaglia.
Carnera, ma il primo su terra italiana. Però il suo trono durò solo un anno, allorché l’1 aprile 1957, al “Palais des Sports” di Parigi, dovette cederlo al francese Alphonse Halimi ai punti, dopo 15 riprese che si tramutarono in una vera battaglia.
Non riuscendo ad avere una nuova chance per il titolo mondiale, si concentrò sul titolo europeo che vinse nel 1957 e nel 1960. Con 67 incontri, di cui 54 vittorie (22 prima del limite), 10 sconfitte e 3 pareggi, si ritirò nel 1962 dopo aver perso ai punti contro il connazionale Federico Scarponi che 5 anni prima aveva battuto per k.o. Ora le sue gesta sono raccontate in un libro, Il canto del gallo, di Alberto Chiodini (Ibiskos Editrice Risolo, 2016). Alla stampa così si descriveva il piccolo grande campione: «Non esistono i sordomuti, non esistono muri invisibili. È la gente che non vede. Io sono stato un uomo fortunato. Madre natura mi ha tolto una cosa, ma me ne ha regalate cento». Era impareggiabile anche nell’umiltà.