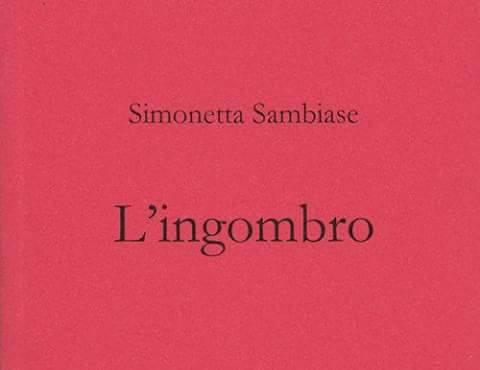A leggere le poesie di oggi, queste (s)composizioni postmoderne e oltre, che ormai contengono in sé (quando sono in effetti poesie e non improvvisazioni) la sapienza dolorosa dei secoli che ci hanno preceduto, quando si legge la poesia, insomma, dopo Montale e Ungaretti, da Fortini e Zanzotto a Sanguineti e Balestrini fino a Jolanda Insana e Valentino Zeichen (tanto per fare qualche nome, perché qualche nome si dovrà pur fare), si ha spesso la sensazione di leggere i frammenti degli antichi lirici greci: non riusciamo a capire tutto, là perché il tempo ha roso il papiro occultando parti di pensiero, qui perché è il poeta stesso che rode continuamente il suo papiro occultando gran parte di sé.
E così si leggono numerose immagini poetiche, belle, ma immerse in una musicalità inafferrabile che risponde più a una musica atonale che non a uno spartito tradizionale.
 Questa musicalità è il frutto di un’operazione da scultore (come pure è stato notato), un “togliere” più che un aggiungere o riempire. Ma, come nei Prigioni di Michelangelo dove l’operazione del sottrarre si ferma a metà lasciando nel non finito un mistero che non va svelato pena la morte dell’opera artistica, la poesia d’oggi vive di una musicalità e di una significatività imperfette, non classicamente fluide. Forma e contenuti obbediscono infatti a una realtà, qual è quella in cui viviamo, per nulla rassicurante.
Questa musicalità è il frutto di un’operazione da scultore (come pure è stato notato), un “togliere” più che un aggiungere o riempire. Ma, come nei Prigioni di Michelangelo dove l’operazione del sottrarre si ferma a metà lasciando nel non finito un mistero che non va svelato pena la morte dell’opera artistica, la poesia d’oggi vive di una musicalità e di una significatività imperfette, non classicamente fluide. Forma e contenuti obbediscono infatti a una realtà, qual è quella in cui viviamo, per nulla rassicurante.
Non fa certo eccezione il caso di Simonetta Sambiase, donna prima che poetessa, con un bagaglio culturale che ha assimilato non solo i nostri poeti più significativi ma anche la cultura femminile (non limitatamente femminista) e la sociologia e filosofia d’oggi (in particolare Bauman, la cui visione del mondo “liquido” è particolarmente presente nella poesia di Sambiase), una poetessa i cui versi somigliano sempre più solo a se stessi, pur avendo i loro antecedenti più immediati in un tipo di versificazione che siamo ormai abituati a leggere (Fortini, Zanzotto, Cucchi, e l’avanguardia a partire da Sanguineti e Balestrini).
Tre anni fa Simonetta Sambiase (che ha al suo attivo altri tre libri di poesia) pubblicava un poemetto intitolato Capo mundi, dove già il titolo, decisiva deformazione in chiave postmoderna di un caput mundi che non esiste più, spiazza il lettore – come notava giustamente nella prefazione Pina Piccolo -, il quale “è chiamato immediatamente ad attivare i neuroni, uscire dagli automatismi grazie a questa commistione linguistica-storica-geografica”. Si trovava forse, in questo poemetto, il momento del distacco dalla poesia tradizionale, in nome di una poetica che tenesse conto dei più recenti apporti filosofici. Così la stessa prefatrice notava sapienti residui di cultura ormai classica (sia sul piano della resa poetica, con perfino un residuo manzoniano, sia sul piano della metrica, con una permanenza significativa dell’endecasillabo) sui quali si innestavano germi consistenti di una nuova versificazione ma anche di una nuova poetica, per la quale forse può bastare la lettura di questa sequenza: “questi passi e trapassi saranno per sempre / nuovi accenti di un mondo liquido / pieno di sopravvissute anime invisibili”. L’altra componente che abbiamo segnalato della poesia di Sambiase, la cultura femminile, era presente nel poemetto già in epigrafe, con una frase di Amalia Nizzoli, la donna che per prima smitizzò l’esotismo imperante sugli harem.
Oggi la poetessa Simonetta Sambiase si presenta con una silloge di 30 poesie, dal titolo altrettanto inquietante quanto il precedente: L’ingombro. Ed anche stavolta siamo costretti a chiederci cos’è l’ingombro, di cosa è metafora, o immagine.
 Dà spiegazioni illuminanti in tal senso la prefazione di Maria Luisa Vezzali, ma qui basterà dire che dalla lettura diretta della silloge pare evincersi che l’ingombro è la componente fondamentale (l’unica?) della nostra vita di oggi, fatta di comunicazione massmediatica debordante e compulsiva, che ci invischia in lacrime artificialmente provocate per nasconderci delle verità che mai sapremo, o che forse potremo almeno in parte apprendere ma con la dolorosa consapevolezza di non poter fare nulla per modificare realtà troppo più grandi di noi individui. Così ad esempio, chi di noi ha mai conosciuto o è mai stato da una campagna mediatica sensibilizzato alla sorte del poeta Ashraf Fayadh (cui è dedicata una poesia)? Condannato a morte in Arabia Saudita, Ashraf Fayadh, pur essendo stato oggetto di grande mobilitazione e di appelli in suo favore sui social, non pare che sia mai comparso in una di quelle lunghe trasmissioni televisive che ci sensibilizzano ogni giorno su singoli casi di cronaca sottoposti ossessivamente alla nostra attenzione per settimane, mesi, anni. Ecco, l’ingombro in questo caso sono quelle trasmissioni televisive: “E come debbo dirlo a mio figlio / che c’è la confusione e ci sono i dolori / che c’è un carnefice ogni cento vittime / e la macchina del mondo gli si muove attorno / annudata in una foto porno che così nessuno la gira / e il male resta sempre acceso e silenzioso” (altrove ha già detto che persino gli uccelli non svernano “se non lo dice il telegiornale”).
Dà spiegazioni illuminanti in tal senso la prefazione di Maria Luisa Vezzali, ma qui basterà dire che dalla lettura diretta della silloge pare evincersi che l’ingombro è la componente fondamentale (l’unica?) della nostra vita di oggi, fatta di comunicazione massmediatica debordante e compulsiva, che ci invischia in lacrime artificialmente provocate per nasconderci delle verità che mai sapremo, o che forse potremo almeno in parte apprendere ma con la dolorosa consapevolezza di non poter fare nulla per modificare realtà troppo più grandi di noi individui. Così ad esempio, chi di noi ha mai conosciuto o è mai stato da una campagna mediatica sensibilizzato alla sorte del poeta Ashraf Fayadh (cui è dedicata una poesia)? Condannato a morte in Arabia Saudita, Ashraf Fayadh, pur essendo stato oggetto di grande mobilitazione e di appelli in suo favore sui social, non pare che sia mai comparso in una di quelle lunghe trasmissioni televisive che ci sensibilizzano ogni giorno su singoli casi di cronaca sottoposti ossessivamente alla nostra attenzione per settimane, mesi, anni. Ecco, l’ingombro in questo caso sono quelle trasmissioni televisive: “E come debbo dirlo a mio figlio / che c’è la confusione e ci sono i dolori / che c’è un carnefice ogni cento vittime / e la macchina del mondo gli si muove attorno / annudata in una foto porno che così nessuno la gira / e il male resta sempre acceso e silenzioso” (altrove ha già detto che persino gli uccelli non svernano “se non lo dice il telegiornale”).
Ma l’ingombro non è solo questo: “La durata dell’ingombro è un millennio di inutili anni / con i ricordi che inghiottiscono la realtà”. Dunque non c’è scampo: l’ingombro non è solo la vita di noi uomini “civili” d’oggi, ma è la stessa vita umana, in cui ci aggiriamo da tempi imprecisabili, recitiamo “a soggetto” (come è detto in un’altra poesia), con la nostra forse vana ricerca del vero, con i nostri agghiaccianti desideri di potenza che generano morti atroci e vite infelici (frequenti, in molte di queste liriche, le allusioni al fenomeno dei migranti e all’atteggiamento cinico di molte persone e di molti paesi nei loro confronti). Di qui alla conclusione che siamo ancora l’uomo della pietra e della fionda, come cantava Quasimodo, il passo è breve.
Questo accorato e doloroso sentire si esprime nella poesia di Simonetta Sambiase attraverso scelte per certi versi estreme, al limite fra la poesia tradizionale e quella sperimentale delle avanguardie: frantumazione metrica, frantumazione sintattica, frantumazione semantica. Basti questo esempio, con l’invito tuttavia a leggere la silloge di filato, lasciandosi trasportare dalla corrente poetica che indubbiamente l’attraversa tutta:
”La tua coscienza fa acqua e pure petrolio / mentre barilotti di fuoco greco attraversano i mari dei benzinai / sulla A14 stanno ancora sbitumando pece e gomme / quattroxquattro e anche l’otto per mille in lega nazionale e patriottica / mai mancante all’appello e tifosa delle partite di serie A / o Zeta5 dove giocano i figli maschi e tutti imprecano all’allenatore / perché, vedete, lo insegnano da secoli anche ai nostri nonni / che il calcio fa bene alle ossa / …”. La commistione improvvisa di campi semantici, non sempre al servizio di una strutturazione in metafore e analogie, dà come risultato un amaro sarcasmo che investe tutto il nostro stile di vita odierno, fatto in ultima analisi di assenza o impossibilità non solo di un’ideologia ma addirittura di una weltanshauung, di una coerente visione del mondo.
Eppure, anche in questa negatività diffusa arrivano, come nel negativo di una vecchia foto, le linee sfocate di valori non rinunciabili, pur se non più organizzate in sistema. Questa è la sensazione che si prova leggendo di seguito le poesie della raccolta di cui stiamo parlando.
È dagli anni Novanta, e ancor più dopo il 2001, che la letteratura ha dovuto fare i conti con una realtà che non permette più illusioni, e così è andato in crisi anche il postmoderno, dando luogo a sensazioni che ormai non ammettono più nemmeno uno smarrimento neocrepuscolare. Nella prosa si affermano i nuovi racconti realistici e a volte iperrealistici, le inchieste, nel cinema i docufilm. Quale può essere l’atteggiamento della poesia in tutto questo?
Simonetta Sambiase certo non ha e non può avere la ricetta risolutiva, e la disperazione deriva anche da questa consapevolezza. Ma la poesia deve farsi carico dei problemi del suo tempo.
E la Sambiase lo fa nel difficile e accidentato percorso poetico di questa raccolta, che si conclude con l’unico testo di tono elegiaco, una sorta di preghiera al lettore, quasi “un’epigrafe conclusiva […] per tessere un rapporto affettivo e una delicata tecnica di congedo con il lettore” (come annota la Pezzali nella prefazione, cui rimandiamo anche per un’analisi della struttura del libro e del suo linguaggio), con un’implorazione al conforto e un richiamo al ricordo visto in una chiave nostalgica che peraltro risulta spiazzante proprio perché non appartiene assolutamente al resto del libro.