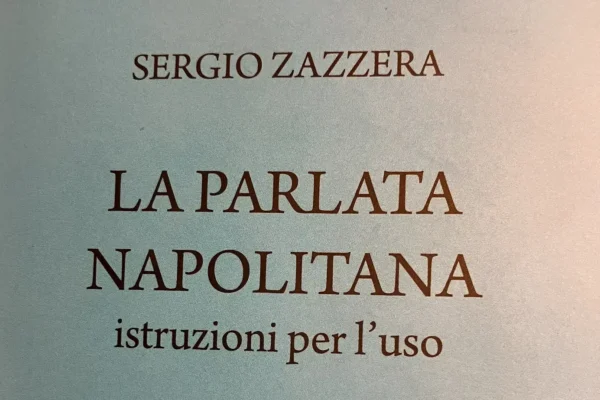Questo corso era nato solo con l’intento di insegnare a scrivere il napoletano in modo corretto e comprensibile, senza approfondire troppo gli argomenti per evitare di annoiare, ma puntando decisamente su poche incontrovertibili norme che si possono agevolmente seguire. Ma poi ci ha preso la mano il gusto di parlare, di narrare, di dialogare.
E così, dopo aver trattato gli elementi essenziali della fonetica e della morfologia, abbiamo pensato di dover rinunciare a trattare la sintassi, argomento adatto ad un corso più ampio ed articolato che non potrebbe essere ospitato in un quotidiano, in cui tutto deve essere più fluido e breve.
E abbiamo parlato del lessico, onde chiarire il senso e i principali usi odierni di parole rimaste nel nostro parlato.
Ma questa strada ci ha portati in un campo “minato”. A ogni pie’ sospinto ci siamo trovati di fronte a incertezze, che potevamo solo in piccola parte affrontare mediante il confronto fra le varie proposte.
Il che è possibile quando ci sono le prove che una ipotesi abbia più forza dell’altra. Ad esempio, il nome Adele deriva certamente dal germanico adel che vuol dire nobile e che troviamo anche in altri nomi (come Adelaide “nobile e bella” e Adelmo “nobile protettore”). E dunque non ci può sviare il fatto che nel greco antico c’è un aggettivo (àdelos) che, declinato al femminile, appare proprio nella forma adèle, e che significa “che non si mostra”, “oscuro”, “invisibile”, il che ci porterebbe ad un affascinante significato del nome come “la misteriosa” (bello, no? Ma indubbiamente falso, anche perché la pronunzia esatta di questa parola greca sarebbe adìli).
Ma quando le prove non ci sono? Restano i ragionamenti dei linguisti, che per quanto sottili possano essere non riusciranno mai ad eguagliare la enorme varietà di casi in cui la lingua cambia, come abbiamo d’altronde cercato di dimostrare quando abbiamo seguito delle parole più vicine a noi nel loro mutamento, prima fra tutte pezzotto, e poi parià, o come quando (nella lezione scorsa) abbiamo azzardato l’ipotesi che molti cambiamenti siano stati provocati semplicemente da bambini.
Facciamo giusto due esempi: i due verbi schizzechià (o schezzechià) e sbarià.
Vi ricordate quella ingenua barzelletta che ci raccontavamo da piccoli quando volevamo solleticare il nostro orgoglio napoletano?
“Ci stanno (si iniziava sempre così) tre amici, un romano, un milanese e un napoletano”, che fanno una scommessa a chi riesce a dire qualcosa usando meno parole. Il napoletano (furbo: sa il fatto suo) propone di dire nel modo più breve possibile che piove poco, a gocce. Lungi dal ricordarci del verbo “piovigginare” (che non ci faceva comodo), facevamo vincere ovviamente il napoletano con l’efficace schezzecheia (che sconfiggeva ignominiosamente i vari “piove fino”, “piove poco” etc).
 Ora sappiamo che esiste piovigginare in italiano, ma non possiamo fare a meno di notare che schizzechià è molto più espressivo, riferendosi alle parole schizzico “goccia spruzzata”, schizza “goccia””, quantità minima” di checchessia, e schizzo “stilla d’acqua o di altro liquido”).
Ora sappiamo che esiste piovigginare in italiano, ma non possiamo fare a meno di notare che schizzechià è molto più espressivo, riferendosi alle parole schizzico “goccia spruzzata”, schizza “goccia””, quantità minima” di checchessia, e schizzo “stilla d’acqua o di altro liquido”).
Il termine viene visto dai linguisti come una formazione onomatopeica dai suoni sk.. e zz.. Esiste nel greco antico un verbo schizo “spacco”, “scindo”, “lacero”, “separo”, “divido”, significati molto evocativi del formarsi di piccole particelle di qualcosa. Se non che, la parola schizzo non sembra per varie ragioni derivare da quel verbo, che ha invece i suoi continuatori in parole del linguaggio colto dal tipico prefisso schizo- (“schizofrenia” etc.). Eppure, dall’idea del tagliare / lacerare / dividere a quella del fare a pezzettini, sminuzzare, e quindi a quella delle briciole e delle gocce, il passo non è lungo… Ma, per quanto il greco sia stato per alcuni secoli (avanti Cristo e poi anche dopo Cristo, col periodo bizantino) più che presente a Napoli, non ne abbiamo le prove.
Ancor più interessante il caso di sbarià, per il quale de Falco propone il verbo greco barèo che significa soprattutto “appesantire” (cfr. barys “pesante” e “basso”, e bàros “peso”, donde anche i composti italiani “baritono”, “barometro” etc.), dal quale fa derivare il senso di “sono oppresso”, “sono assillato”, qual è appunto chi sbaréa nel senso di essere pazzo, vittima di ossessioni.
Invece D’Ascoli, che dà per sbarià il senso “vaneggiare”, “delirare”, “farneticare”, lo mette in relazione col vicino italiano “svariare”. Il verbo svariare in italiano vale “rendere vario” e quindi piacevole, per cui “svagare”, o anche “deviare”.
Ora, sbarià in napoletano è usato in entrambe le accezioni: “essere pazzo” e “perdersi in pensieri vari” (e vani) o in attività varie (e vane). Supporre che il primo senso abbia influito sul secondo o viceversa il secondo sul primo sono affermazioni che possono essere in qualche misura entrambe vere. Dunque potrebbe benissimo derivare la parola dal greco barèo (in tal caso o in epoca antichissima, il che non è dimostrabile, o in epoca bizantina, il che, a quanto ci risulta, non è ancora dimostrato), oppure dal latino ex-variari, con la premessa di un prefisso ex (come è avvenuto nel passaggio di molte parole dal latino al parlato volgare, cioè alla lingua moderna).
Ma potrebbe anche essere vera una terza ipotesi: il greco barèo, diventato sbarejà, potrebbe essersi incontrato con uno “svariare” italiano e aver dato luogo alla nostra voce più ricca di significato rispetto all’una e all’altra, inglobando i significati da entrambe le voci. Ma chi può dirlo, in assenza di prove? Dobbiamo sospendere il giudizio.
Ecco perché arrivati a questo punto riteniamo di non dover proseguire su questa scia, almeno in questa sede, ricordandoci che il nostro intento era unicamente di promuovere una scrittura corretta o almeno comprensibile del napoletano in quelle persone che, a qualunque titolo, lo scrivono (e sono oggi veramente molti).
Resta solo da spiegare il titolo di quest’ultima pagina con la quale ci congediamo (non per sempre, sperabilmente) dai nostri lettori.
Scompetura è una parola non più in uso, ma che significa semplicemente “fine”, e deriva dall’altrettanto desueto verbo còmpere “compiere” (con la s intensiva). Era la parola che si poneva anticamente alla fine di un testo letterario in dialetto napoletano, così come nei testi italiani e nei film c’era FINE, in quelli angloamericani THE END, in quelli francesi FIN.