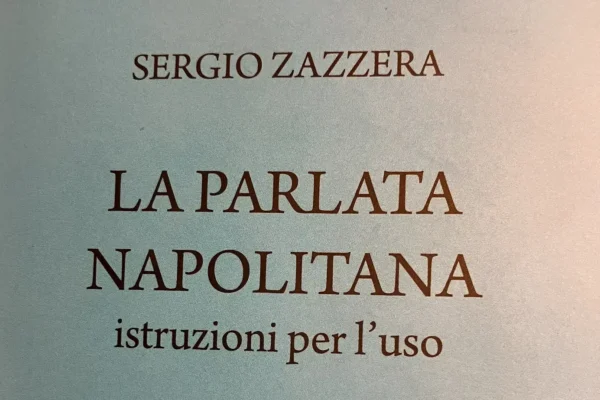Oggi ci è venuto a trovare il poeta Andrea Zanzotto: parliamo di linguaggio, o meglio, tenteremo. La poetica di Zanzotto indaga acutamente nei meandri di una ricerca letteraria diacronica, attraverso l’inconscio del linguaggio e il dialetto della sua terra, il Veneto (Filò, per es., è un suo volume dove il dialetto veneto esce dal suo uso comune), avvitata tra la langue e la parola con un enorme serbatoio psicanalitico a dimostrare l’esistenza d’una memoria lucida tra segno e senso all’interno del corpus linguistico.
Un’opera, quella dell’autore di Pieve di Soligo, sempre originalissima e liberamente creativa, capace di comporsi attraverso il linguaggio che comunque rifiuta la realtà avvilente  circostante dentro una corsa-rincorsa e uno strenuo confronto retorico e fonetico con la natura e le sue metamorfosi. Il punto sinestetico del linguaggio zanzottiano è nel paesaggio, nel rapporto tra significato e significante, referente e oggetto, rottura dei codici per sperimentare l’evento, la natura, la scienza, la storia: è su questa strada che si verificano le condizioni d’instabilità dei codici per una ulteriore chiave di lettura. L’assunzione naturale di un enorme vortico di elementi verbali significanti, di citazioni estrapolate dalla storia di un linguaggio passato e fortemente sentito, ci dimostra una non/trascurabile propensione alla materialità (del non-dato), e di conseguenza all’impossibilità di convivere coi significati da… macello.
circostante dentro una corsa-rincorsa e uno strenuo confronto retorico e fonetico con la natura e le sue metamorfosi. Il punto sinestetico del linguaggio zanzottiano è nel paesaggio, nel rapporto tra significato e significante, referente e oggetto, rottura dei codici per sperimentare l’evento, la natura, la scienza, la storia: è su questa strada che si verificano le condizioni d’instabilità dei codici per una ulteriore chiave di lettura. L’assunzione naturale di un enorme vortico di elementi verbali significanti, di citazioni estrapolate dalla storia di un linguaggio passato e fortemente sentito, ci dimostra una non/trascurabile propensione alla materialità (del non-dato), e di conseguenza all’impossibilità di convivere coi significati da… macello.
È una poesia pluralistica, questa di Zanzotto, fatta di citazioni di citazioni, per un movimento materico e una manipolazione di una langue poco logica ma non illogica, per l’abolizione del soggetto ma non dell’io, per una poesia intesa come esperienza individuale (che è poi, secondo Zanzotto, l’io della natura, l’io del mondo e della scienza), piena di ansie e interrogativi, restrizioni del campo semantico per un non/campo semantico, una mescolanza magmatica di silenzio e mormorio, entro i quali la materia divarica e s’intreccia con tutti i registri, o la maggior parte di essi.
Ha una sua definizione del linguaggio poetico?
Credo che un linguaggio “vivo” viva rinnovando continuamente se stesso, superando il limite dell’assurdo, costituendo coi termini lacaniani un punto sinestetico per il lettore. Si tratta di affrontare dimensioni di profondità originaria da un massimo di vigilanza e tensione mentale, e all’interno d’un contesto storico-culturale che non viene mai accantonato, ma che giace sull’orlo di un precipizio: ora, sull’orlo, sta / anche per tutto il mio / mancare.
E il suo, su che si basa?
Ha varie posizioni di lettura come deve essere un sistema linguistico che fonda e organizza l’esperienza della parola arbitrariamente rispetto alla realtà. È imprevedibile il linguaggio creativo: feci la mia tesi sul linguaggio “verista” di Grazia Deledda ma scoprii il linguaggio simbolista di Rimbaud, e quello di Hölderlin. Una folgorazione!

Da più parti la critica ha classificato la sua poesia nel contesto idilliaco. Che può dire a questi critici?
È vero, in quanto io stesso riconosco la presenza del “fanciullino” nel mio poetare, come ha sottolineato Antonielli, un fanciullino che riscopre il mondo, ricomincia da capo, e si stupisce, s’affanna, ha paura. C’è da aggiungere soltanto che la poesia idilliaca sa che il linguaggio è (tutto sommato) un continuo sperimentare gli abissi umani: è scavare con le mani la terra su cui si vive.
Ma oggi non si può scrivere come Leopardi.
Sono d’accordo. E proprio per questo ch la mia poesia, pur rimanendo in un mondo idilliaco, emerge anche rompendo i canoni abusati della tradizione, per es. nell’uso allitterato di unire o raddoppiare parole: puro-pura; movimento-mancamento; cose-cause; questi-quaggiù; cicala-ciàcola; poemi-pomi; pappa-pappo, etc. Per dare vitalità, ma anche per altri piani di lettura.
Cosa si sente di dire a chi oggi compone o s’avvicina alla poesia?
A volte dissacrando i contenuti, altre volte estrapolando l’ironia da un linguaggio originario come lo è quello dell’infanzia, per una poesia come esperienza individuale, denunciando l’irrealtà quotidiana per una poesia fisica ma anche metafisica alla realtà.
Perché a volte?
Ragazzo, io sono Zanzotto, ritenuto un poeta neo-classicheggiante, anche se ho pubblicato una prova sperimentale che è Il Galateo in bosco. Ed è già tanto che lasci entrare qualche parola “dissacrante”, o mi sia avvicinato allo strutturalismo di tipo lacaniano.
C’è stato un periodo, gli anni ’60, che lei ha criticato fortemente i Novissimi (Sanguineti e compagnia). Soltanto perché appartenevano ? diciamo così ? all’altra parrocchia, alla neoavanguardia? La spaventa questo movimento?
Io non sono contro le innovazioni. Sia ben chiaro! Le innovazioni, anche in poesia, sono la rigenerazione dei sentimenti, del pensiero. Detto questo, pero, un codice sperimentale si deve spostare verso  un impegno che è quello di sprofondare nell’inconscio e tentare di svelarlo. Essi invece hanno fatto passare come antimito il mito del dissacratorio a tutti i costi per scuotere le coscienze, che è quello poi di più metalinguistico che ci possa essere nella mia poetica: un significante come ricerca di significati altri. E sappiamo tutti che fine hanno fatto i Novissimi rispetto ai loro intenti: la poetica è diventata una posizione politica per occupare posti di potere.
un impegno che è quello di sprofondare nell’inconscio e tentare di svelarlo. Essi invece hanno fatto passare come antimito il mito del dissacratorio a tutti i costi per scuotere le coscienze, che è quello poi di più metalinguistico che ci possa essere nella mia poetica: un significante come ricerca di significati altri. E sappiamo tutti che fine hanno fatto i Novissimi rispetto ai loro intenti: la poetica è diventata una posizione politica per occupare posti di potere.
Dunque, e per terminare, lei nel periodo dei Novissimi operava all’organizzazione mentale dello spazio creativo per una rilettura “controllata” di quei moduli già ritenuti (da altri) erroneamente archiviati? E quei moduli di linguaggio a volte alogico, oggi sono riproponibili?
Esorcizzando il linguaggio per un flusso energetico totalmente versato nella trama del vissuto; il linguaggio poematico deve essere del mondo e nel mondo dell’interrogazione, con l’illusione, magari, non tanto di bloccare il tempo, quanto di penetrarlo e guardarlo al di là dell’angoscia del tempo presente, al di là del potere, al di là della nostra appartenenza alla morte, per una poesia inventariale che riflette sul linguaggio e l’esperienza umana.