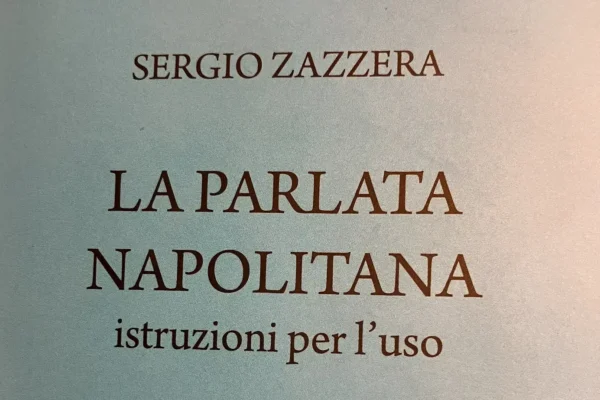Oggi ci è venuto a trovare il fantasma di Walter Benjamin, filosofo, scrittore, critico letterario e traduttore di Proust e Baudelaire. Benjamin nasce a Berlino nel 1892, in una ricca famiglia ebraica dedita all’antiquariato e al commercio. Muore a Portbou (Spagna), nel 1940. Amico di Gershom Scholem, col quale stringe amicizia nel 1915, matematico e filosofo che avrà un ruolo importante nello studio di Benjamin sull’ebraismo e sul rapporto tra esso e la filosofia. Un’altra amicizia importante nella vita e nell’evoluzione intellettuale di Benjamin, è stata quella intercorsa, sin dal 1928, con Bertolt Brecht. Si laurea a Berna nel 1919, ma rifiutata la sua domanda di libera docenza presso l’Università di Francoforte, si dedica alla critica e alla saggistica, infittendo legami con personalità della cultura a lui contemporanea (oltre con Scholem e Brecht, con Rosenzweig, Bloch e Adorno). Approfondisce lo studio tra la mistica ebraica e il marxismo, analizzando importanti autori (Goethe, Kafka, Baudelaire, ecc.), con interessi sul pensiero della modernità. Nel 1933, in pieno potere nazista, si stabilisce a Parigi, e nel settembre del 1939, in quanto cittadino tedesco, con lo scoppio della guerra, viene rinchiuso in un campo di lavori forzati. Scrive le Tesi sul concetto di storia, il suo ultimo lavoro e testamento spirituale che troverà gloria e notorietà postumo, come d’altronde tutte le sue opere. Quando nel 1940 Parigi viene occupata dai tedeschi, Benjamin fugge verso la Spagna per imbarcarsi verso gli Stati Uniti. Ma quando arriva a Port Bou, una località catalana, gli viene ritirato il visto di transito. Per timore di essere catturato dalla polizia spagnola di frontiera, con l’inevitabile espulsione dalla Spagna per far ritorno in Francia, ormai completamente sotto assedio dai nazisti. Preso dal panico si suicida con una overdose di morfina.
Maestro, vorrei farle alcune domande.
Di dov’è lei?
Di Napoli.
Ah, Napoli. Ricordo che il 19 agosto del 1925 pubblicai con la mia amica Asja Lacis una corrispondenza di viaggio dedicata a Napoli sulla «Frankfurter Zeitung», un giornale tedesco, uno dei pochi democratici del tempo.
Se non ricordo male Asja Lacis la conobbe a Capri.
Sì, giusto. È grazie alla sua influenza che ho cominciato ad interessarmi di marxismo per cui mi sono avvicinato al comunismo, anche grazie alla lettura di Storia e coscienza di classe di Lukács. È di questo periodo un mio articolo su Goethe per l’Enciclopedia Sovietica (una mastodontica opera che metteva in luce la rilevanza internazionale nei campi dell’economia, della scienza e della cultura raggiunta dai russi) e un soggiorno a Mosca, nell’inverno del ’27, cioè tra il ’26 e il ’27. Al ritorno mi ritrovo con una serie di articoli sulla Russia del periodo del NEP (Nuova Politica Economica), un sistema di riforme economiche, istituito da Lenin nel 1921 e che durò fino al 1929. Sono fiero di essere stato un comunista, anzi, un ebreo comunista.

Aveva un potere seduttivo la Lacis non da poco, a quanto pare.
Una donna bellissima che incantò gli intellettuali degli anni venti. Insieme abbiamo scritto anche il Manifesto per un teatro proletario dei ragazzi. Con lei il teatro irrompe nella strada e la strada nel teatro. Mi raccontava dei besprisorniki, gli omologhi dei vostri scugnizzi, bambini abbandonati che vivevano per le strade, nelle piazze dei mercati, nei cimiteri, nelle cantine, nelle case distrutte, che si guardavano intorno come vecchi: occhi stanchi, tristi, nulla li interessava. Bambini senza infanzia, difficili da avvicinare che vivevano in branco, come cani randagi per le vie di Orel. Grande impegno il suo, di vera comunista, una vera rivoluzionaria della pedagogia. Con approccio antiautoritario creò dei laboratori di teatro per sezioni in cui i bambini recitavano, sviluppavano l’occhio, la vista, dipingevano, disegnavano, seguivano un’educazione musicale, l’addestramento tecnico al ritmo, alla ginnastica, alla dizione e all’improvvisazione. Insomma, un teatro per i bambini fatto da bambini.
Oggi quel tipo di comunismo è praticamente scomparso, anzi è scomparso proprio il comunismo, scioltosi come neve al sole. In Italia, per es., resistono strettissime sacche disomogenee e discordanti tra esse. Una sua definizione di comunismo?
Il comunismo rappresenta, per colui che è stato derubato dei suoi mezzi di produzione interamente, o quasi, il tentativo naturale, razionale di proclamare il diritto a questi mezzi, nel suo pensiero come nella sua vita.
C’è qualcuno che l’accusa di troppa “libertà” di opinione, non sempre in grado di definire con la sua filosofia la vera distinzione tra diritto e giustizia.
Non sono mai riuscito a studiare e a pensare altrimenti che in un senso che potrei definire teologico, ossia in conformità con la dottrina talmudica dei quarantanove livelli di significato di ogni passo della Torah. Orbene, l’esperienza mi insegna che la più logora delle banalità comuniste ha più gerarchie di significato che l’odierna profondità borghese, che ha sempre e soltanto quello dell’apologetica.
Non ho capito granché. Comunque, ritornando al suo viaggio dalle mie parti, grazie alla sua metafora sulle pietre tufacee e le grotte e le caverne del luogo, Napoli si porta dietro l’etichetta di “città porosa”.
Sì, ricordo. Scrissi che Napoli era porosa come questa pietra è l’architettura. Struttura e vita interferiscono continuamente in cortili, arcate e scale. Dappertutto si conserva lo spazio vitale capace di ospitare nuove, impreviste costellazioni. Il definitivo, il caratterizzato vengono rifiutati. La vita privata del napoletano è lo sbocco bizzarro di una vita pubblica spinta all’eccesso. Non è tra le mura domestiche, tra moglie e bambini, che essa si sviluppa, bensì nella devozione o nella disperazione.
Non è poi cambiata di molto, a quanto pare. Insomma: tradurre la vita in essenza?
Esattamente. Testimoniare una contraddizione all’estetizzazione del misticismo irrazionale, agli effetti negativi della società capitalistica. L’alienazione dovuta dal mercato più vieto, ci ha rimandati nella preistoria, passando da soggetti ad oggetti. C’è bisogno del ripristino della morale della modernità.
È risaputo che una delle caratteristiche più notevoli dell’animo umano, è la generale mancanza di invidia del presente verso il proprio futuro. Ce lo dice anche Lotze. Allora, come può ritrovare la felicità il presente?
La riflessione porta a concludere che l’idea di felicità che possiamo coltivare è tutta tinta del tempo a cui ci ha assegnato, una volta per tutte, il corso della nostra vita.
Mi scusi, ma n on riesco a seguirla.
Intendo dire che la felicità che potrebbe suscitare la nostra invidia, è solo nell’aria che abbiamo respirato, fra persone a cui avremmo potuto rivolgerci, con donne che avrebbero potuto farci dono di sé.
Mi sa che stamane mi sono svegliato con le pile scariche! Ancora non riesco a seguirla, ma una cosa ho capito: la felicità è momentanea e non ha futuro, nasce e muore nel momento in cui la s’incontra. È così?
In altre parole, nell’idea di felicità, vibra indissolubilmente l’idea della redenzione.

Allora la felicità serve per redimerci?
Sì, ma ci impone pure una intesa segreta fra le generazioni passate e la nostra, ed è tutta nella nostra attesa sulla terra da parte di chi ci ha preceduti il dato più nobile della felicità. La vera immagine della felicità è un attimo, passa di sfuggita. Solo nell’attimo della sua conoscibilità, si lascia fissare nel passato e rischia di svanire ad ogni presente, già nel momento in cui appare. D’altronde, quando uno dice “come eravamo felici un tempo”, il sapore della felicità non ha tempo, rimane nei nostri ricordi a sovrastare ogni dolore, ogni pericolo. Quando invece uno dice “come sono felice”, nel momento in cui lo dice, l’azione muta, muta anche il concetto di felicità che si riduce a strumento di persuasione, di redenzione, appunto. In altre parole, la felicità spesso si presenta come nemica, come desiderio indissolubile e non smette di vincere.
La tradizione degli oppressi!
Già. La tradizione degli oppressi ci insegna che lo stato di emergenza in cui viviamo di giorno in giorno, è la regola. Dobbiamo giungere a un concetto di storia che corrisponda a questo fatto. Avremo allora di fronte, come nostro compito, la creazione del vero stato di emergenza che è la totale crisi di identità, non già quella materiale, e ciò migliorerà la nostra posizione antagonista al capitalismo, al pensiero unico e alla globalizzazione delle idee.
Insomma, viviamo un presente che fa letteralmente schifo!
Il presente, con la crisi economica e dell’individuo, è archeologia, risultato di una lettura distorta e sconvolgente della modernità in una materializzazione degli affetti e una costituzione dell’individualità umana in lotta per il suo riconoscimento. Una società che si palesa come nemica è un’assurdità. Essa, l’umanità, è ben altro da un segno matematico, da un conteggio o un’esposizione di merce esposta al mercato. In questa “volontà violenta” consiste l’attualità. Questa violenza la riscontriamo anche in poesia. Anche qui il seme di una produzione artistica si lascia strappare dal conflitto delle forze scatenate dell’economia. Di conseguenza, la poesia si svolge oggi più che mai in una sfera separata dal popolo attivo, consumati da un’ambizione di visibilità nella cui soddisfazione, nonostante tutto, i poeti del passato furono più fortunati dei nostri.

È ancora possibile la lotta di classe educata su Marx che non sia la semplice immagine di una preda destinata al vincitore?
Certo. Solo se la lotta di classe fosse destinata al popolo. Ma è un’esigenza che gli uomini non hanno mai corrisposto in pieno, rinviando il momento in cui la lotta sia corrisposta. Ma la lotta di classe non è mai corrisposta; anche quando ciò accade si manifesta in tutta la sua intraducibilità e atarassia, in quanto l’essere umano è un individuo abituato a rapportarsi col proprio intimo piuttosto che non la persona che ha davanti. Tanto è vero che quando si affermano, le lotte di classe, si elevano nell’ periodo in cui sorgono, per poi sopravvivere fino ad annullarsi nel periodo che segue. Questa sopravvivenza, quando viene alla luce, prende il nome di gloria, che tende a sottrarsi al confronto dei mutamenti generazionali con conseguenze speculative.
Bah! Sarà… Dalle mie parti si dice “finché le persone riescono a mettere un piatto di minestra a tavola, nulla accade, nessuno protesta o si ribella”. E quando ciò accade è un attimo di allegoria, estremamente condizionata dall’abitudine di guardarsi dentro piuttosto che guardare in faccia la realtà.
Il dilemma è proprio questo, appunto: la gente non è più in grado di proporre una resistenza collettiva che sappia mediare tra la rabbia e le aspettative.
Un pensiero sulle donne.
Difficile argomento. Ho vissuto follemente l’attrazione per il gioco e per le donne. Al gioco ho quasi sempre perso, in quanto alle donne non le ho mai conosciute fino in fondo. Una donna la conosce solo colui che l’ama senza speranza. Ma il mio giudizio è irrilevante: sono stato un narcisista assoluto, un uomo devastato, inaffidabile, un “uomo invisibile”, come mi ha definito il mi o amico e protettore Gershom Scholem, lo studioso di mistica ebraica. Quindi, le mie parole valgono come neve sciolta al sole. Ma poi siamo sicuri di saper conoscere le donne fino in fondo, penetrando quella cortina di diffidenza che le protegge?
Insomma non ne esce bene, Maestro, neanche dal ritratto di una persona spietata che ne fa sua moglie Dora Kellner, che la definisce “tutto cervello e sesso, il resto ha smesso di funzionare. Quest’inverno ha vissuto con me quattro mesi, mi è costato un sacco e non ha mai messo, di suo, una lira. Mentre spendeva e spandeva con Asja. Non ha mai messo un soldo da parte per Stefan, nostro figlio, o per me; e ora mi chiede di prestargli metà della mia futura eredità, quella che mi verrà da mia zia”. Ora due parole sull’arte. Qual è il suo compito?
Uno dei compiti principali dell’arte è sempre stato quello di creare esigenze che al momento non è in grado di soddisfare.
C’è speranza per il futuro di dare un po’ di felicità all’umanità?