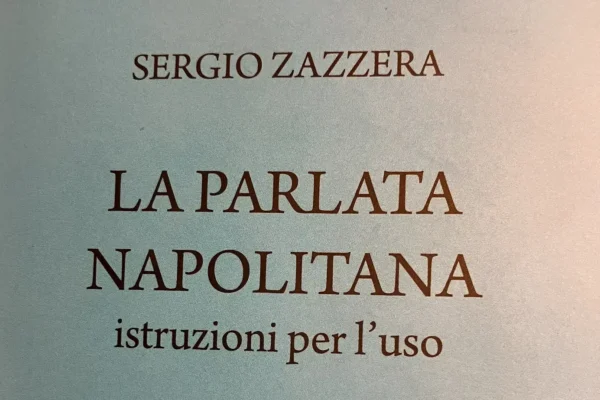Oggi ci è venuto a trovare il fantasma di Maurice Blanchot, uomo engagé, critico letterario, giornalista fino al 1940, collaborando con «Critique» e «La Nouvelle Revue Française», e filosofo francese, nato a Quain, nel 1907 e morto a Le Mesnil-Saint-Denis, nel 2003). È stato anche autore di romanzi e racconti: Thomas l’obscure (1941; 2ª ed. 1950); Aminadab (1942); L’arrê de mort (1948); Le Très-Haut (1948); Le Renassement éternel (1951); Au moment voulu (1951); Celui qui ne m’accompagnait pas (1953); Le dernier homme (1957); L’attente, l’oubli (1962). Come critico, teorico della letteratura e semiotico, ha pubblicato: Comment la littérature est-elle possible? (1942); Faux-pas (1943); La part du feu (1949); Lautréamont es Sade (1949); L’espace littéraire (1955) Le livre à venir (1959); L’Entretien infini (1969); L’amitié (1971).
Ci apprestiamo a fare questa intervista, ma attacca prima lui con una affermazione spiazzante.
Io sono il più grande tra i critici letterari francesi.
Alla faccia della modestia! Incominciamo bene! Senta, questa intervista non si doveva neanche fare, in quanto alcuni amici mi avevano esortato a non concedergliela. Mi dicevano: «Ma come, fai un’intervista ad uno che è stato di destra?». Li ho risposto dicendo che m’interessava l’altro Blanchot, quello che nel secondo dopoguerra ha fatto parte della sinistra. Quindi, cerchi di non rompere e si renda conto che lei oggi sarebbe etichettato come un “politico scorretto”, un “voltagabbana”. Parliamo del suo L’infinito intrattenimento. Scritti sull’“insensato gioco di scrivere”. Oggi com’è la salute della letteratura?
In tutti i paesi e in tutte le lingue si pubblicano continuamente dei libri (e questo ci fa già comprendere che almeno prosegue), alcuni dei quali passano e altri restano nel tempo, anche quando il concetto di libro si sarà svuotato, sostituito dagli e-book.
Ma questo già lo sapevamo.
Tuttavia è necessaria un’osservazione preliminare: da Mallarmé in poi qualcosa tende a rendere sterili queste distinzioni.
Distinzioni di cosa?
Attraverso di esse, ma ben più importante, è venuta in primo piano l’esperienza di quella che continuiamo a chiamare letteratura, ma con una nuova serietà. Pareva che saggi, romanzi e poemi esistessero e fossero stati scritti solo per permettere al lavoro della letteratura di compiersi, ma che tuttavia una secolare tradizione estetica eludeva ed elude tuttora.
Vuol dire che la letteratura è ancora legata ad una tradizione ormai “fuori luogo”?
Esattamente!

Ma resta l’esigenza di scrivere, la realizzazione di quello che l’uomo pensa e divulga attraverso il linguaggio, ancor prima la volontà di rimanere tracce di sé attraverso la scrittura. Quindi, per questo si guarda più al passato che al presente, dove forse ci si imbatte in più certezze, anche se svuotate ormai del loro significato. Ma forse è perché siamo degli incalliti conservatori?
Non credo che questa condizione sia superata e mai la supereremo. L’incerto ci spaventa, da sempre, anche se ci incuriosisce, ma ci andiamo cauti, Dire il contrario non avrebbe senso, visto che anche la natura tiene alla sua conservazione. Ma come dimostra la magnifica esperienza surrealista, qualunque cosa si faccia o si scriva, la letteratura la fa sua e ancora una volta ci si trova nella civiltà mummificata del libro.
Allora la letteratura, prodotto del pensiero umano, deve comunque garantire una conservazione?
No. Essendo un’esperienza totale, una domanda che non sopporta limiti, il lavoro e la ricerca letteraria contribuiscono a scalzare i principi e le verità che la letteratura – ossia, i libri –, garantisce. Abbandonarsi alla magia del percorso aggirante, non più protetto dal centro, ma in sua balia. Per conservare servono i libri. I libri servono a conservare il mondo in cui trovano rifugio l’ideale e l’essenziale, il divenire incessantemente in divenire nella profondità del luogo. I libri sono libertà o morte, rimando ad un niente di esistenza e di presenza. Conservano le esperienze, le idee, i pensieri, le verità, le finzioni, in correlazione con certe possibilità del sapere, del discorso e della lotta poetica, perché all’origine c’è proprio la ripetizione, la conservazione, l’eterno re-immaginare, affermati delle opere con più insistenza.
Ma perché si ha l’esigenza di scrivere? L’oralità non basta? Lei, per es., perché scrive?
Scrivo per negare l’esistenza di quello che scrivo, ma nego anche l’esistenza di colui che lo legge. È strana la letteratura, non è come la filosofia che è scienza del pensiero, la letteratura è assoggettata allo spirito e al sentimento, due supporti destinati a mutare a seconda della realtà circostante o interiore.
È la questione del linguaggio conservativo (l’oralità è destinata alla dispersione) che probabilmente li rovescia e li colloca nella loro semplicità della tradizione per non ammettere le difficoltà della scrittura?
Fa parte dell’insensato gioco dello scrivere (l’oralità non ha di queste problematiche). Ma l’esigenza della irragionevole conservazione della scrittura, deve realizzarsi non più attraverso quella che si è sempre messa al servizio della parola o del pensiero cosiddetti idealisti, ossia moralizzatori, postmodernisti, ma attraverso una scrittura che, con la sua forza lentamente sprigionatesi nella forza aleatoria d’assenza, che però non si consacri a se stessa.
Restando senza identità?
Ma che cos’è in fondo l’identità? L’avvenimento che ci ripromettiamo di evocare un domani, quando i giochi saranno diversi però e ci si aspetta dall’altro una conferma di sé, che in realtà non arriva mai come l’originale, quella che Benjamin, riferendosi all’arte, definisce riproducibilità tecnica che non è dissimile ad una riproducibilità identitaria: troppe fattori nel frattempo sono mutati.
E come avviene tutto ciò?
Dal momento in cui una parola, una frase si insinua fra due entità, qualcosa è già cambiato, una storia è già finita. È la parola che crea la nostra identità, il linguaggio che ci appartiene e che muta tra intervalli e distanze tra noi e la realtà. E può accadere che le due cose, identità e linguaggio, per astuzia, per viltà, per antinomia di una eteronomia, si mescolino, pur diversificate l’una dall’altro: la vita li tiene uniti, e potrebbero risultare entrambi soddisfatti, non fosse altro per l’imposizione della parola, una parola supplementare che non è solenne, non cambia la luce del tardo mattino.
Ma è l’idea di Mallarmé! Allora tutto si compie nell’origine della parola, “origine ab ovo”, come affermava il poeta Emilio Villa?
C’è nella vita di un uomo – e quindi dell’umanità – un momento in cui tutto è compiuto, i libri sono scritti, silenzioso l’universo, gli esseri in riposo. Ma poiché questa parola supplementare rischia di turbare l’equilibrio, non la si pronuncia e l’opera rimane incompiuta, l’uomo rimane incompiuto nella ricerca dell’origine.

Quindi, potremmo fare a meno dei libri?
Quando parlo dell’assenza del libro (e mi segua, attentamente), non intendo alludere allo sviluppo dei mezzi di comunicazione audiovisivi che preoccupa tanti specialisti innamorati della carta stampata. Se anche si smettesse di stampare libri a vantaggio di una comunicazione attraverso la voce, l’immagine o la macchina, la realtà di ciò che si chiama “libro” non muterebbe; al contrario, il linguaggio, in quanto parola, riaffermerebbe ancor più saldamente il suo predominio, la sua certezza d’una verità possibile. Il libro, insomma, indica sempre un ordine subordinato all’unità, un sistema di nozioni in cui si afferma il primato della parola sulla scrittura, del pensiero sul linguaggio, e la promessa di una comunicazione che un giorno – si spera – sarà immediata o trasparente.
A questo punto mi domando: cosa vuol dire scrivere, perché scrivere?
Il componimento di tutto ciò che preserva la nostra cultura. Ma così è molto semplice. Invece, scrivere è un radicale cambiamento della storia e quindi scrivere diventa una tremenda responsabilità.
Allora la scrittura è chiamata a distruggere il discorso che disponiamo, per quanto infelici possa farci sentire?
Lo scrivere da questo punto di vista è la più grande delle violenze, in quanto trasgredisce ogni legge e la sua stessa legge. Essa va separata tra la parola quotidiana inessenziale (servile) e la parola poetica de costruttiva (resistente), una parola intransitiva che non serve, nel senso di servitù; essa non significa, è; l’essenza della poesia sta nella ricerca della propria origine. È una parola errante, come la definisce Freud, intollerante verso il romanticismo e l’innamoramento di sé (orfismo). Tutt’altra che democratica, come è osannata da Todorov, a discapito della rimozione del diverso, dell’altro da sé, che sottrae il pensiero dal vincolo dell’assoluto, espressione hegeliana, aprendo una breccia nel nostro vissuto, basato sulla conoscenza piuttosto che sulla coscienza, e l’attenzione altrui, in un’apertura incrociata: dalla letteratura alla filosofia per poi far ritorno alla letteratura, come dice Derrida, che è un modo indiretto di espressione.
L’immaginario, ovvero il riflesso di un qualcosa, di un’idea, di un pensiero, ci ossessiona nella solitudine esistenziale e nella solitudine del mondo. In questa nostra esistenza catastrofica dovrebbe aiutare a portarci al di “fuori”, verso un “altrove”. Invece ci facciamo distogliere dagli eventi negativi o spesso ci facciamo condizionare fino al punto di cadere in “tristezza”. Quale contributo può darci l’immaginario affinché questa “tristezza” diventi estremamente innocua?
Per prima cosa occorre definire che cosa si intende per immagine. Quando non vi è nulla, l’immagine trova in ciò la sua condizione, ma vi sparisce. L’immagine domanda la neutralità e la cancellazione del mondo, vuole che tutto rientri nel fondo indifferente in cui niente si afferma, tende all’intimità di ciò che sussiste ancora nel vuoto. Superba potenza, dice Pascal, che fa dell’eternità un nulla e del nulla una eternità. Il contributo che ce ne viene è la felicità. Sì, sembra strano, ma ci trasmette felicità, perché attraverso ciò che vi è di inflessibile in un riflesso, non ci crediamo padroni dell’assenza divenuta intervallo, e lo stesso vuoto compatto, che sovente avvertiamo intorno a noi, sembra aprirsi all’irraggiamento di un altro giorno. Il suo contributo, ovvero, uno dei contributi, consiste nel fatto che essa è un limite rispetto all’indefinito, Tenue cerchio, ma tale che non ci tiene tanto in disparte dalle cose quanto ci preserva la pressione soffocante della quotidianità. Così l’immaginario-immagine svolge una delle sue funzioni che è quella di placare, di umanizzare l’informe nulla, che il residuo ineliminabile dell’essere spinge verso di noi. Ed ecco la felicità!

Sempre più spesso si pensa al suicidio, negli ultimi tempi ce ne sono stati molti, ad eliminare la vita propria e altrui (penso alle numerose donne che hanno incontrato la morte per mano di mariti gelosi o fidanzati lasciati). Siamo legati alla vita come siamo legati alla morte, ma perché pensiamo di risolvere tutto con la morte che è un danno alla vita?
Nessuno pensa alla morte. Accade. Nessuno è legato alla morte da una vera certezza perché nessuno è sicuro di morire, e quando decidiamo di sopprimere un nostro simile è un atto estremo della nostra coscienza ma non c’convinzione dell’eliminazione fisica. Caino, quando uccise Abele, non era nelle condizioni di certezza assoluta di eliminare fisicamente il fratello, perché ognuno di noi, pur ammettendo la realtà della morte, non può pensare alla morte certa se non in termini di dubbio, perché pensare alla morte è introdurre nel pensiero ciò che è sommessamente dubbio, lo sgretolamento del non-sicuro, ed è per questo che si arrivi al gesto finale: in fondo alla nostra coscienza agiamo o pensiamo alla morte senza coscienza, come una fuga, perché la morte stessa è eterna fuga davanti alla morte, perché essa è la profondità della dissimulazione. Ma nascondersi da essa è come nascondersi in essa: ed ecco il dubbio che si pensa o si agisce non pensando alla morte ma a un desiderio di rifiuto della realtà.
Quindi è la coscienza, lo spirito che dispone le azioni, la realtà?
Valery affermava che tale disposizione avviene su due piani: prendiamo una poesia, i versi sono esperienze, connesse all’approccio alla vita, ad un movimento che si compie nella serietà e nel lavoro della vita. Per scrivere un solo verso, bisogna aver dato fondo alla vita. Poi l’altra affermazione: per scrivere un solo verso, bisogna aver dato fondo all’arte, bisogna aver dato fondo alla vita nella ricerca dell’arte. Ma da dove viene ciò che scriviamo, da noi, da una possibilità di noi stessi o dall’ambiguità dell’unno e dell’altro? Le azioni sono di due tipi: esercizio puro proveniente dallo spirito che dispone delle forme; esercizio precario della forma che si fa corpo e potenza di spirito. Nel primo caso, essendo un atto puro, tende a non compiere niente; nel secondo caso, è indifferente al senso e allo spirito, tende a una perfezione di cosa fatta. Dunque, le cose accadono a prescindere dal nostro stato.
Allora è tutta una finzione, la vita?
Non è facile dirlo, perché la vita è un’esigenza imperiosa e vuota.
È ancora tollerabile oggi proporre una scrittura cosiddetta “passatista”, assoggettata ai poteri della politica-spettacolo e dell’industria culturale, o una scrittura cosiddetta “antagonista? Ma che cos’è la scrittura?
Scrivere è entrare nell’affermazione della solitudine, dove incombe la fascinazione. È consegnarsi al rischio dell’assenza del tempo, dove regna l’eterno riconoscimento. È passare dall’Io all’Egli, di modo che ciò che mi avviene non avviene a nessuno, è anonimo per il fatto che mi concerne, si ripete in uno sparpagliamento infinito. Scrivere, è disporre il linguaggio sotto la fascinazione e, per mezzo di esso, in esso, restare in contatto con l’area assoluta in una solitudine essenziale. La solitudine che viene allo scrittore dall’opera si rivela in questo: scrivere è l’interminabile, l’incessante. Lo scrittore non appartiene più al dominio magistrale dove esprimersi significa esprimere la certezza e l’esattezza delle cose e dei valori secondo il senso dei loro limiti. Ciò che scrive rimanda colui che deve scrivere a un’affermazione sulla quale non ha più autorità. Lo scrittore appartiene ad un linguaggio che nessuno parla, che non si rivolge a nessuno, che non ha centro, che non rivela niente. Scrivere per non morire, affidarsi alla sopravvivenza delle opere, è quanto lega l’artista al proprio compito.
Riusciremo un giorno ad essere felici come i norvegesi? Ma che cos’è la felicità?
Un buon cibo, pasta tutti i giorni, una fetta di pane con un filo d’olio extravergine, una sfogliatella ed un cannolo. Allontanandoci, però, dai piaceri della tavola, la felicità per uno scrittore è la responsabilità, l’abuso e il travestimento di fronte alla scrittura, l’assenza che ritorna alla presenza; quando tutto è sparito nel fondo della notte, la sparizione diventa, in quel ritorno, lo spessore dell’ombra che rende la carne più presente, la presenza più greve e più estranea, senza nome e senza forma: preservare in ciò che non comincia mai, questa è la felicità. Quando il desiderio si realizza, scompare la felicità.