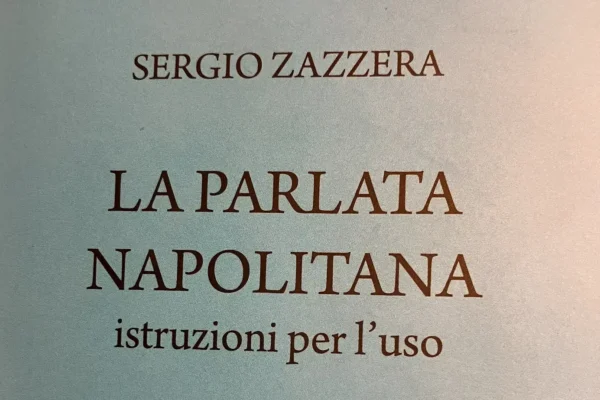Oggi ci è venuto a trovare l’artista Julian Beck, il fondatore del “Living Theatre” che proprio quest’anno ha compiuto settant’anni dalla nascita.
Incominciamo con una domanda per sciogliere il ghiaccio. Chi è Julian Beck?
Sono nato a New York il 31 maggio 1925 dove sono morto il 14 settembre 1985. Sono stato un attore e regista teatrale, poeta, pittore e saggista. Sono cresciuto in una famiglia ebraica. Dopo aver frequentato la Yale University, mi dedico alla pittura astratta e divento amico di Jackson Pollock. Poi, quando conosco mia moglie Judith Malina, ad entrambi ci prende la passione per il teatro, fondando il Living Theatre che ho co-diretto con mia moglie fino alla sua morte. Ho anche partecipato a progetti cinematografici: “Edipo re”, “Cotton Club”, “Poltergeist II – L’altra dimensione”, “Amore e rabbia”, un episodio del film che Bernardo Bertolucci diresse nel 1967.
Avete avuto problemi particolari all’inizio della vostra attività di teatranti?
Direi siamo stati abbastanza fortunati, forse per la scelta di proporre Antonin Artaud, il teorico del “Teatro della crudeltà”. Questa scelta, ma vorrei sottolineare anche un pizzico di bravura, fa sì che la nostra compagnia teatrale sperimentale si insedia stabilmente nel panorama di Broadway, il tempio del teatro newyorkese. Ma essendo indisciplinati, anarchici e controcorrente, la compagnia riesce anche a proporre e realizzare lavori fuori dai canoni tradizionali, basati su temi forti per l’epoca e l’ambiente, come “The connection” di Jack Gelber; “The brig” e “Many loves” che affrontava il problema dell’omosessualità. Il mio è un teatro politico, della gioia, di liberazione, rivoluzionario, underground.
Poi decidete di fare un tour europeo, come fanno le grandi star. Cosa ricorda della sua tournée in Italia?
Ricordo che fu la prima del tour europeo. Eravamo nel 1961. Presentammo “The Connection” a Roma, Torino, Milano e alla Biennale Teatro di Venezia. Fummo accolti bene, ma la strada dell’avanguardia teatrale, come molti sanno, in Italia era già stata tracciata da quel fenomeno che è Carmelo Bene e le sue contestazioni stereotipate, come al “teatro di regia”.
Scusi l’ignoranza: facciamo capire bene ai nostri lettori cosa s’intenda per “teatro di regia”?
Semplice. La risposta ce l’ha dà la stessa denominazione. Ovvero, un’ascesa negli ultimi decenni dell’Ottocento di un processo che porta all’affermazione di un nuovo sistema di spettacolo imperniato sulla centralità della figura del regista, Il teatro di regia: genesi ed evoluzione, 1870-1950, proclamandosi il solo custode dell’intangibilità del testo che trovò il consenso del mondo intellettuale. In Italia è uscito un bel libro, molto esplicativo sull’argomento, “Il teatro di regia: genesi ed evoluzione, 1870-1950”, di Umberto Artioli, pubblicato da Carocci nel 2004.

Ci sono tracce per chi oggi vorrebbe studiare il suo pensiero di rinnovo dell’ambiente teatrale?
Due saggi: “La vita. L’artista e la lotta del popolo” e “Theandric. Il testamento artistico del fondatore del Living Theatre”.
Quando è importante la narrativa nel teatro?
È importante perché se il teatro deve essere il mondo non può trascurare quanto avviene, la transizione da un momento all’altro. Particolari esperienze come spugne di inchiostro blu lanciate contro un vetro verde possono incantare l’occhio, ma la persona che lancia la spugna è sempre più interessante dell’inchiostro che schizza. II problema è fare un teatro in cui questo sia chiaro. La tua mano che porta alle labbra la familiare tazza di caffè è qualcosa di più che una bistecca vermiglia nel cielo della sera: qualunque cosa tu faccia supera ogni paesaggio, bisogna chiarirlo. Se vogliamo sopravvivere al paesaggio.
E la poesia?
Ho sempre creduto in un teatro come luogo di esperienza intensa fra sogno e rituale, durante il quale lo spettatore perviene ad una comprensione intima di se stesso, al di là del conscio e dell’inconscio, sino alla comprensione della natura delle cose. Mi è parso che solo il linguaggio della poesia arrivi a questo: solo la poesia o un linguaggio carico di simboli e molto distante dal nostro linguaggio quotidiano può condurci al di là del presente che non ha la chiave della conoscenza di questi regni.
A proposito di poesia. Lei ha pubblicato tre libri di poesia (“Rivoluzione e controrivoluzione”; “60 quaderni dal 1952 al 1963”; “Quaderni dal 1969 al 1985”), in cui emergono, tra le altre, un accenno alla sua battaglia contro la pena di morte statunitense e una ballata per la morte dell’anarchico italiano Giuseppe Pinelli dal titolo “Pinelli Baader manifesto” e («…il corpo di giuseppe pinelli cade / come cadono nel buco del tempo tutti i corpi di tutti i prigionieri di tutte le prigioni del mondo / e tutto il mondo è una prigione tenuta dallo stato / e dovunque c’è una prigione c’è anche uno stato…»). Ci può descrivere brevemente la sua poesia?
Le mie poesie sono il tentativo di registrare la dimensione epica della mia vita nei termini dei cambiamenti che ho sperimentato, che rappresentano il background e il grido del mio tempo. Le poesie registrano una progressiva visione e comprensione della realtà, dei suoi problemi, lacune e soluzioni. Le soluzioni assumono inevitabilmente la forma di cambiamento rivoluzionario. Le poesie registrano la mia disperazione, che credo sia la stessa dei miei contemporanei. Questa disperazione apre la strada al progetto rivoluzionario, le poesie sono un’invocazione che provoca visioni.
Cosa insegna la poesia agli attori?
Che uno deve recitare tutto con tal convinzione, che deve fare sì che la forza della verità, la forza dell’amore e la forza della vita siano irresistibili per tutti gli altri attori con noi sulla scena, in maniera tale da trascinarli nel rituale magico di girare la ruota e riportare la terra al suo gioioso stato di cambiamento creativo. Ma sia ben chiaro, ognuno differente da un altro, ognuno individuo, ma tutti in relazione uno con l’altro, reciprocamente indipendenti. Insomma, senza dell’altro non esistiamo.
Come possiamo metterci in relazione l’uno con l’altro?
Nutrire tutti, arrestare tutte le guerre, aprire le porte di tutte le prigioni, disintegrare la violenza, obliterare il razzismo, liberarci del denaro, finirla col militarismo, porre fine ai sistemi autoritari, finirla con questa storia del sistema di classe.

Lei una volta ha scritto: «La struttura sociale è la prigione del mondo. La nostra battaglia è penetrare dentro le possibilità dell’essere». Ha a che fare con la sua idea anarchica sulle orme di Artaud?
Nulla è più naturale del cambiamento. L’anarchia non è nient’altro che questo. L’anarchia deriva semplicemente dal riconoscere tale fatto, esattamente come il corpo cambia da secondo a secondo, come le stagioni, come l’età dell’uomo, come questo pianeta dalla preistoria attraverso la preistoria marxiana, la storia fino a oggi, fino alla successiva evoluzione. Dinosauri e uccelli dodo arrivano e spariscono, e noi? L’anarchico vuole creare le condizioni in modo che il processo, il processo dell’universo, continui fino al massimo sviluppo effettivo della vita e della gioia. Un principio dell’anarco-comunismo: se cambi l’economia cambierà anche la mentalità, quando vivremo in comunità noi tutti saremo diversi.
Il suo teatro ha rotto con la convenzionalità, con il linguaggio classico del teatro. Cosa intende per rottura di linguaggio?
La rottura del linguaggio equivale a una rottura di valori, dei sistemi dì discernimento, della ragione malata. Rottura del linguaggio significa invenzione di nuove forme di comunicazione. Rottura del linguaggio significa rottura dei calcolatori elettronici. Rompi il linguaggio delle forze in controllo e romperai la loro stanca logica, romperai la loro struttura ermetica. Scuoti le cose, cambia, abbandonati alle cose che non comprendiamo, ciò che crediamo di capire non lo capiremo in nessun modo, la nostra logica è falsa, è rigida e sistematica, aprila. Respira. Liberare il linguaggio (pensiero) dai limiti della ragione socratica, che è ora l’arma polente della democrazia imperialista dominante. Togliamo via alla classe dominante il linguaggio per sottoporlo all’immaginazione, turbolenza della mente. Breton. Questa negli anni ‘20 fu chiamata “Rivoluzione della Parola”, ma ora non la limitiamo solo alla letteratura. Libera associazione, come l’ordine del futuro, come opposizione all’associazione irreggimentata della struttura societaria che domina il corpo e lo spirito del nostro tempo.
Che cosa ha rappresentato per lei il “Living Theatre” che ha costituito con sua moglie Judith Malina?
Il teatro non era più per noi un fine, ma semplicemente un mezzo per raggiungere determinati strati sociali, per conoscere la loro problematica e stabilire un contatto con essi. Abbiamo cominciato così a liberarsi della schiavitù del testo scegliendo semplicemente dei temi da illustrare sfruttando le esperienze della nostra vita di ogni giorno a contatto con una popolazione appartenente ai più infimi strati sociali, che avevamo eletto a nostra sola interlocutrice e collaboratrice.
Come nasce il “Living Theatre”?
Quando andammo da Robert Edmond Jones nel 1947 per parlargli del nostro teatro lui rimase molto entusiasta e ci chiese di tornare nuovamente. Lo facemmo, io gli porsi i miei progetti scenici e parlammo dei lavori che ci proponevamo di fare. Parlammo molto, ma ci sembrava molto triste e gli chiedemmo perché. All’inizio, disse, pensavo che aveste la risposta, che foste veramente sul punto di creare il nuovo teatro, ma vedo che state solo facendo domande. Quanti soldi avete? 6000 dollari, risposi. Peccato, disse, vorrei che non aveste proprio denaro, assolutamente niente, allora forse potreste creare il nuovo teatro, costruire il vostro teatro con spaghi e cuscini di poltrone, farlo in studi e soggiorni. Dimenticate i grandi teatri, disse, e l’ingresso a pagamento, là non succede niente, niente altro che istupidimento, non verrà mai fuori niente di lì. Se volete prendetevi questa stanza, disse, offrendoci il suo studio, se volete iniziare di qui potete averla.
Immagino che ci rimaneste male, forse la vostra idea di teatro alternativo non era ancora pronta per essere accolta?
Non posso negare che rimanemmo delusi dalla proposta e rifiutammo. Il nostro teatro, d’altronde, non era basato poi tanto sulla volontà di scardinare i canoni del teatro classico, bensì di avere un successo simile agli spettacoli che si tenevano a Broadway.
Poi l’avete costituito il vostro teatro.
Il 26 aprile 1948, con atto notarile, ufficializzammo la costituzione della nostra compagnia, ma ci mancava una sede dove rappresentare i nostri spettacoli. Non eravamo interessati al teatro di quel tempo, ritratto di persone subumane, e tutto patriottismo, il patriottismo è il passatempo degli sciocchi, quando non è quella passione per il paese e il suo popolo che è l’ardore dell’amante. Sebbene la semplice immagine del teatro contemporaneo fosse già sufficiente al precipitare di una rivoluzione. Iniziammo con rabbia. Tutto il teatro sano di quel tempo era al di sotto della dignità di donne incinte e uomini validi. All’altezza dello spettatore c’era solo qualcosa di folle, gesti cavati fuori dalle viscere degli attori, inconsci come i movimenti di un bruco, appendici palpitanti come spilli che entrano nel torace, mani di annegati, messaggi anonimi ricevuti nel sonno.

Dovevate avere una grande stima di voi stessi e del teatro che sognavate per non arrendervi alle evidenze.
Andavamo a teatro continuamente, Judith e io. Tutto ci interessava e ci infuriava. Due tre quattro volte la settimana. In questo modo, nel 1946, Judith già sapeva di non voler lavorare in quel teatro. Io continuavo a dipingere in quel periodo, mi occorsero sei mesi per arrivarci; decidemmo di costituire un teatro che avrebbe fatto cose diverse. Credevamo anche che ci fosse una specie di ritardo sociologico nello sviluppo del teatro. Cioè, leggevamo Joyce e Pound, Breton, Lorca, Proust, Patchen, Goodman, Cummings, Stein, Rilke, Cocteau, la pittura di Pollock e De Kooning che implicava una vitalità sconosciuta al teatro, un livello di consapevolezza e inconsapevolezza raro a trovarsi sulla scena.
Nel frattempo che il vostro sogno si realizzasse, come impegnavate le vostre giornate?
Judith studiava con il regista teatrale tedesco Erwin Piscator, un avanguardista del teatro. Egli sapeva che politica radicale e azione sociale erano la strada. Parlavamo di anarchia, beat generation, marxismo, mitologia e metrica greca, sogni e Freud, discorsi giovanili; camminavamo nei boschi lungo Palisades [Boschi lungo la costa del New Jersey di fronte Manhattan], andavamo molto al mare, bellezza da spiaggia. Probabilmente la nostra valutazione più profonda: che gli anni ‘40 non furono l’apogeo del successo umano, ma che tuttavia in quel decennio si ebbe, disperata, tutta la gloria che il mondo potrà mai contenere. Il problema di trovare, ordinare, ricostituire la materia, sentire, e essere. Un teatro per tutto questo.
Torniamo alla realizzazione del “Living Theatre”. Come ci riusciste?
Quattro anni più tardi dall’incontro con Jones, incapaci di trovare un teatro in cui lavorare, decidemmo di dare alcuni lavori nel nostro soggiorno senza far pagare o spendere un centesimo. Funzionò, aveva ragione. Ma non avevamo ancora capito completamente. Per cui abbiamo avuto teatri con pubblicità commerciale, prezzo d’ingresso e pagamento di tasse. Come se da questo potesse accadere qualcosa, la glorie, forse. Dentro la trappola. Nel riconoscere di esserci dentro abbiamo almeno iniziato a discutere le strategie per uscirne fuori.
La linea guida del suo teatro?
Liberare il pensiero dai limiti della ragione socratica, che è ora l’arma polente della democrazia imperialista dominante. Togliamo via alla classe dominante il linguaggio per sottoporlo all’immaginazione, turbolenza della mente, agganciandoci al surrealismo di Breton, al dada di Tzara, all’assurdo di Ionesco. Questa negli anni ’20 – come ho già detto ? fu chiamata “Rivoluzione della Parola”, ma ora non la limitiamo solo alla letteratura. Libera associazione, come l’ordine del futuro, come opposizione all’associazione irreggimentata della struttura societaria che domina il corpo e lo spirito del nostro tempo. Il percorso centrale, insomma, è il rapporto tra attore e spettatore. Stabilire un rapporto amoroso con gli spettatori, non più fingere la vita ma viverla.
Per concludere. A quale spettacolo è più legato?
A “Frankenstein”, presentato nel 1965 proprio in Italia, al “Festival del Teatro” di Venezia, che rappresenta forse lo spettacolo più compiuto e riuscito sul piano strettamente teatrale.