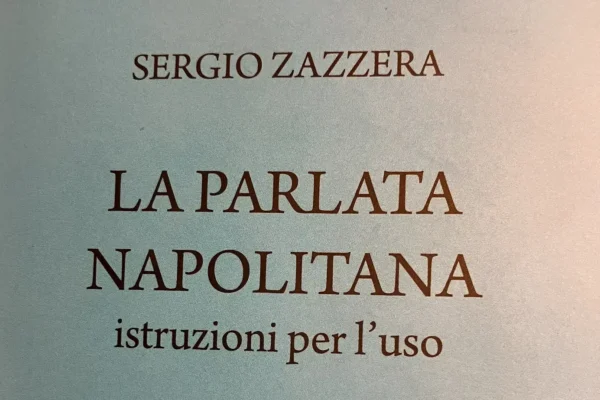Per presentare il filosofo, scrittore e drammaturgo francese, chiediamo soccorso ad un ottimo scritto di Stefano Lanuzza, Jean-Paul Sartre “nausea” dell’outsider (in «Malacoda», n. 4, 2017): «Parigino, Jean-Paul Sartre (Parigi, 21 giugno 1905 – 15 aprile 1980) è un controverso ma certo tra i più rappresentativi, dinamici, ubiqui e liberi intellettuali del Novecento: colui che, da oppositore, da eterno outsider, dà la sveglia all’Europa della svagata Belle Époque e delle due Grandi Guerre, e più d’ogni altro, per tutta la sua vita, si batte senza risparmio contro la rassegnazione conformistica e lo status quo governato dal liberalismo capitalista.
Ciò che subito segue, anche nell’ambito di talune caste culturali italiane, è un’astiosa, penosa rincorsa al ridimensionamento e alla demonizzazione dell’intellettuale e dell’uomo: del “cattivo maestro” colpevolmente vicino (invero non senza distinguo anche “contro se stesso”: non senza incontri-scontri, ripensamenti e leali ammissioni di errori) a un marxismo da riformare, all’alternativa anticapitalistica, all’antimperialismo, anticolonialismo e antirazzismo; all’Algeria, Armenia, Ungheria; al Vietnam, ai fatti di Praga e alla dissidenza nei paesi dell’Est; alle rivolte dei popoli contro la tirannia, lo sfruttamento del lavoro e la tortura legalizzata; alla contestazione giovanile e ai movimenti sessantotteschi nati dalla crisi della morale cattolica e dell’ipocrisia perbenista».
Cosa aggiungere di più per inquadrare la figura di questo importante intellettuale del Novecento? Che nel 1964 rifiutò il Nobel per la letteratura, convinto che solo dopo la morte sia possibile esprimere un giudizio sul valore di un letterato, ma soprattutto perché lo riteneva un premio troppo filoamericano? E che nel 1945 rifiutò anche la Legion d’onore e la cattedra al Collège de France? Le sue opere: (romanzi) La nausea, 1938; Il muro, 1939; L’età della ragione, 1945; Il rinvio, 1945; La morte nell’anima, 1949; Œuvres romanesques, 1981; (teatro) Bariona o il figlio del tuono, 1940; Le mosche, 1943; A porte chiuse, 1944; La puttana rispettosa, 1946; Morti senza tomba, 1946; Le mani sporche, 1948; Il diavolo e il buon Dio, 1951; Kean, 1954; Nekrassov, 1955; I sequestrati di Altona, 1959; Le Troiane, 1965; (critica letteraria) La repubblica del silenzio, 1944; Baudelaire, 1946; Che cos’è la letteratura?, 1948; San Genet, commediante e martire, 1952; L’Idiota della famiglia, 1971-1972 su Flaubert; Un teatro di situazioni, 1973; Critiche letterarie; Mallarmé, la lucidità e il suo volto d’ombra, 1986; (filosofia); L’Immaginazione, 1936; La Trascendenza dell’Ego, 1937; Idee per una teoria delle emozioni, 1938; L’immaginario, 1940; L’essere e il nulla, 1943; L’esistenzialismo è un umanismo, 1945; Materialismo e rivoluzione, 1947; Coscienza e conoscenza di sé, 1947; Questioni di metodo, 1957; Critica della ragione dialettica I. Teoria degli insiemi pratici, 1960; Quaderni per una morale, 1983; Critica della ragione dialettica II. L’intelligibilità della storia, 1985; Verità e esistenza, 1989; etc.
Uno dei suoi libri migliori s’intitola La nausea. Nauseato dal mondo o da se stesso? Dentro o fuori di sé?
La nausea non è in me: io la sento laggiù sul muro, sulle bretelle, dappertutto attorno a me. Fa tutt’uno col caffè, sono io che sono in essa.
Come definirebbe la nausea, una cosa o un sentimento?
Il percepire l’altrui sguardo, sotto il quale io non mi trovo libero ma mi sento una cosa. Dopotutto, non io sono nauseato; bensì è la nausea ad assediarmi. Una nausea che intride le cose e m’insidia, marca pesantemente l’intera esistenza, non si fa circoscrivere e avvolge la verità del reale nel suo vischio dolciastro tentando di tramutarmi in oggetto tra oggetti indifferenziati e inidentificabili, privati d’ogni possibile trascendenza.

Perché allora definire nausea lo sguardo altrui su di sé? Non sarebbe più facile ignorare questi sguardi? Col suo bagaglio filosofico sarebbe un gioco da bambini, anche se non sempre i giochi da bambini sono sempre semplici.
Non riesco a svincolarmi da quegli occhi che mi gravano addosso ostacolando la mia autodeterminazione. Tutto congiura contro la mia libertà, pure il mio passato e l’amore che vorrebbe collocarmi nei suoi effimeri schemi. Non c’è niente che non riguardi la mia emancipazione: eccetto la morte che non appartiene alla mia libera scelta e diviene la massima negazione della libertà. Tuttavia è la nausea che mi pone di fronte all’Essere facendomi avvedere che esisto.
Lei considerato, a torto, un filosofo della disperazione. Non c’è affermazione più sbagliata! Direi un filosofo dell’esistenza che attraverso la “nausea” del mondo si porta oltre la nausea, nel tentativo di trascendere dal non-senso della Storia e dalle sue inutili catastrofi. Lei afferma che non bisogna riflettere troppo sul valore della storia. Cosa ci vuole dire?
Innanzitutto non bisogna avere paura della storia, se ci presentiamo ad essa con una testamentaria volontà di cambiamento da attuare nell’azione, nell’impegno politico e culturale, nell’emanciparsi dalle paure. Non bisogna riflettere troppo sul valore della Storia, ma ricercare la libertà da tutto, la libertà per tutti.
Dunque, dobbiamo armarci di pazienza di vivere?
La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla; sta a voi darle un senso, e il valore non è altro che il senso che sceglierete. L’esistenzialista non prenderà mai l’uomo come fine, perché l’uomo è sempre da fare.
Un po’ l’idea del pensiero debole oggi vigente?
Indebolire un pensiero per farlo comprendere non è poi gran male.
Non siamo d’accordo, ma ci adeguiamo. Un passaggio sull’esistenzialismo, questa nuova dottrina filosofica nata nel secondo dopoguerra, di cui lei è considerato uno degli elementi di spicco, alla pari (forse) dei tedeschi Karl Jaspers e Martin Heidegger, il suo connazionale Albert Camus, gli italiani Nicola Abbagnano e Luigi Pareyson, i russi Lev Sestov e Nikolai Berdjaev.
Cominciamo col dire che l’esistenzialismo non è estraneità dalla società, ma un umanesimo, è la vita. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla, sta a voi darle un senso, e il valore non è altro che il senso che scegliete. Così vedete che c’è la possibilità di creare una comunità umana. Vorrei qui difendere l’esistenzialismo da un certo numero di critiche che gli sono state mosse. Innanzitutto lo si è accusato di indurre gli uomini ad un quietismo di disperazione, poiché, precluse tutte le soluzioni, si dovrebbe considerare in questo mondo l’azione del tutto impossibile e sfociare, come conclusione, in una filosofia contemplativa; il che, essendo la contemplazione un lusso, ci riconduce ad una filosofia borghese. Tali soprattutto le critiche dei comunisti, ma i cattolici non sono stati da meno. Altro non aggiungo. Non mi va. Datti una risposta da solo, andando a leggerti gli scritti a riguardo.
Va bene. Allo parliamo un po’ del suo teatro. Colpiscono immediatamente inquietanti profezie sulla crisi della civiltà occidentale capitalista e consumistica. Ci parli del suo teatro.
Il mio è teatro di situazioni. Niente più caratteri: gli eroi sono altrettante libertà prese in trappola, come tutti noi. Quali sono le vie d’uscita? Ogni personaggio non sarà che la scelta di una via d’uscita e varrà la via d’uscita scelta. In un certo senso ogni situazione è una trappola da sorci; muri da ogni parte. Il mio teatro, che è “nuovo teatro”, rappresenta un uomo che è libero nei limiti della sua propria situazione, e che sceglie, lo voglia o no, per tutti gli altri, quando sceglie per sé. Mi servo del teatro per rendere in concreto il mio pensiero, in contrapposizione al teatro psicologico borghese tradizionale: la libertà gratuità porta all’angoscia umana. L’Essere e il nulla è l’angoscia umana, l’assurdo è il corrispettivo dell’esistenza, dove l’uomo non è più padrone della situazione.

Tra i giovani lei è diventato icona di ribellione e di anticonformismo del dopoguerra. Penso ai sessantottini francesi che la presero a modello. Anche quando passa dalla militanza nel Partito Comunista Francese ad una posizione anarco-comunista, abbandonando il marxismo-leninismo. Eppure lei ha affermato che se «la classe operaia vuole distaccarsi dal Partito (PCF), essa dispone solo di un mezzo: ridursi in polvere» e in altro contesto, in Critica della ragione dialettica (Il Saggiatore, Milano, 1976), «Lungi dall’essere esaurito, il marxismo è ancora giovanissimo, quasi nell’infanzia: ha appena cominciato a svilupparsi. Esso rimane dunque la filosofia del nostro tempo: è insuperabile perché le circostanze che l’hanno generato non sono ancora superate». Perché questo passaggio che s’intravede anche nel saggio breve Il fantasma di Stalin. Dal rapporto Kruscev alla tragedia ungherese?
Trovai inammissibile l’esistenza dei campi di concentramento sovietici, ma trovai altrettanto inammissibile l’uso giornaliero che ne faceva la stampa borghese. È invero che Kruscev ha denunciato Stalin, però senza fornire sufficienti spiegazioni, senza avvalersi di un’analisi storica, senza prudenza, quasi come se la condanna in toto dell’esperienza sovietica non lo riguardasse. Occorre riconoscere, attraverso gli errori, le mostruosità e i crimini, gli evidenti privilegi del campo socialista e condannare, con tanta maggior energia, la politica che mette in pericolo questi privilegi. Non fu un cambiamento di idee. Da sempre sono stato più anarchico che marxista. Se si leggono i miei libri, si capirà che non sono mai cambiato in profondità, e sono sempre rimasto un anarchico. Comunque un anticomunista è un cane, su questo sono irremovibile e lo sarò sempre.
La libertà dell’uomo spesso s’infrange contro la realtà storica, un umanesimo esistenziale dove la libertà di realizzarsi come uomo-dio e ineludibilmente sempre un dio-fallito. Ciò che evidenzia il fallimento è vivere una libertà fasulla, basata sul nulla. Ma che cos’è per lei la libertà?
Posto che l’uomo è condannato ad essere libero: condannato perché non si è creato da se stesso, e pur tuttavia libero, perché, una volta gettato nel mondo, è responsabile di tutto ciò che fa, la libertà, è ciò che si rivela nell’angoscia, in grado di caratterizzarsi con l’esistenza di quel niente che si insinua tra i motivi e l’atto. Non già perché ci sentiamo liberi, il nostro atto sfugge alla determinazione dei motivi, ma, al contrario, il carattere inefficiente dei motivi è condizione della nostra libertà.
Perché ha rifiutato il Nobel?
Non voglio essere letto perché Nobel, ma solo se il mio lavoro lo merita.
L’assegnazione di questo Premio farebbe felice quasi tutti i letterati, li riempirebbe di gioia, ma a lei no!
Non credo che la felicità esista; credo che esista soltanto la gioia. La gioia è quando ci si sente nel pieno delle proprie forze, della propria intelligenza, del proprio potere; quando si compie un’azione, un’azione difficile, e si riesce ad ampliare con essa il potere dell’uomo. Non il proprio potere soltanto, ma quello dell’uomo. Penso per esempio che un Gagarin o un Cooper abbiano conosciuto la gioia. Anche il lavoro nel momento in cui si fa dà gioia, anche perché è il lavoro che definisce l’uomo.
Rispetto ad un altro grande pensatore del Novecento e maestro dell’Esistenzialismo, il tedesco Heidegger, che sosteneva una esistenza oggettiva, lei propugna per una soggettiva. Cosa significa per lei il soggettivismo?
Soggettivismo vuol dire, da una parte, scelta del soggetto individuale per se stesso e, dall’altra, impossibilità per l’uomo di oltrepassare la soggettività umana. Questo secondo è il senso profondo dell’esistenzialismo. Quando diciamo che l’uomo si sceglie, intendiamo che ciascuno di noi si sceglie, ma, come questo, vogliamo anche dire che ciascuno di noi, scegliendosi, sceglie per tutti gli uomini. Infatti, non c’è un solo dei nostri atti che, creando l’uomo che vogliamo essere, non crei nello stesso tempo una immagine dell’uomo quale noi giudichiamo debba essere. Scegliere d’essere questo piuttosto che quello è affermare, nello stesso tempo, il valore della nostra scelta, giacché non possiamo mai scegliere il male; ciò che scegliamo è sempre il bene e nulla può essere bene per noi senza esserlo per tutti. Se l’esistenza, d’altra parte, precede l’essenza e noi vogliamo esistere nello stesso tempo in cui formiamo la nostra immagine, questa immagine è valida per tutti e per tutta intera la nostra epoca. Così la nostra responsabilità è più grande di quello che vorremmo supporre perché coinvolge l’umanità intera. Così sono responsabile per me stesso e per tutti e creo una certa immagine dell’uomo che scelgo. Scegliendomi, io scelgo l’uomo.
E l’assunzione teorica del materialismo storico marxiano?
Nulla a che vedere con dottrina comunista sovietica, in quanto propone una visione della società che lascia agli individui larghi spazi di libertà e di affermazione. Nella fattispecie, non è né nell’attività dell’organismo isolato e né nella successione dei fatti fisico-chimici che la necessità si manifesta: il regno della necessità è il dominio, reale, ma ancora astratto dalla storia, dove la materialità inorganica si chiude sulla molteplicità degli uomini e trasforma i produttori nei loro prodotti. La necessità, come limite nel seno della libertà, come evidenza accecante e come momento del rovesciamento della praxis in attività pratico-inerte diventa, dopo la caduta dell’uomo nella società seriale, la struttura stessa di tutti i processi di serialità, quindi la modalità della loro assenza nella presenza e di una evidenza svuotata.
Lei accetta il pensiero di Marx, ma in buona sostanza rifiuta il materialismo dialettico di Engels. Perché?
Il modo di produzione della vita materiale domina in generale lo sviluppo della vita sociale, politica e intellettuale. Questa dialettica può effettivamente esistere, ma bisogna riconoscere che non ne abbiamo la benché minima prova. È un dogma acritico, non sa più di nulla: i suoi concetti sono diktat; il suo fine non è più di acquistare cognizioni, ma di costituirsi a priori come sapere assoluto, mentre l’esistenzialismo rinascere, riuscendo a mantenersi perché afferma la realtà degli uomini.
Qual è la sua idea sulla rivoluzione?
Nessuno afferma che le rivoluzioni siano facili. Se definiamo il progresso come l’aumento della gente che partecipa alle decisioni che riguardano la sua vita, non ci possono essere dubbi che, oltre ai massacri, ai genocidi, agli omicidi di massa che hanno abbondantemente segnato la storia dell’umanità, c’è stato un progresso. Occorre riconoscere, attraverso gli errori, le mostruosità e i crimini, gli evidenti privilegi del campo socialista e condannare, con tanta maggior energia, la politica che mette in pericolo questi privilegi. Occorre riconoscere, attraverso gli errori, le mostruosità e i crimini, gli evidenti privilegi del campo socialista e condannare, con tanta maggior energia, la politica che mette in pericolo questi privilegi.
Le rivoluzioni sono destinate al fallimento?
Hanno fallito! Una rivoluzione che dà per scontato che per sopravvivere deve schiacciare a sinistra e a destra, come fece Robespierre, come fece Stalin, deve per forza fallire. Ma Che Guevara è stato l’essere umano più completo della nostra epoca.
L’opinione pubblica, almeno una buona parte, non l’ha mai vista di buon grado. Lo diceva anche lei poc’anzi a proposito dell’esistenzialismo. La sua filosofia è ritenuta una epoché emotiva, angosciosa. Inoltre, troppo filosovietico, marxista, simpatizzante della rivoluzione cubana, diffusore di un’etica libertina e scandalosa, degenerato, e un’accusa pesante: quella di aver giustificato il terrorismo.
Come ultima arma politica contro le forze nemiche. Una terribile arma, ma i poveri oppressi non ne hanno altre.
Qual è la sua posizione verso l’amore?
 Non mi sono mai dispiaciuti i ménage à trois. Quando stavo con Simone de Beauvoir, il nostro amore si poteva definire “amore aperto”, rivoluzionario per quei tempi. Il nostro era un amore necessario, ci conveniva conoscere anche degli amori contingenti, quelli occasionali di sesso femminile, amanti di Simone che era bisessuale. Fui ritenuto un immorale, perfino pederasta. Soltanto quando avremo cominciato a sbarazzarci del tabù dell’incesto (tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle), avremo raggiunto la totale libertà. Quel che conta è l’intenzione. L’uomo non è niente altro che quello che progetta di essere; egli non esiste che nella misura in cui si pone in atto; non è, dunque, niente altro che la somma dei suoi atti, niente altro che la sua vita. Da questo possiamo comprendere perché la nostra dottrina faccia orrore a un certo numero di persone. Perché, spesso, esse hanno un solo modo di sopportare la loro miseria, ed è di pensare: le circostanze sono state contro di me, io volevo molto di più di quello che sono stato. Non sento di essere il prodotto del caso, un granello di polvere nell’universo, ma qualcuno che era aspettato, preparato, prefigurato. In breve, un essere che solo un Creatore potrebbe mettere qui. E questa idea di una mano creatrice si riferisce a Dio, anche se si tratta di un Dio assente, che è più grande del Dio presente.
Non mi sono mai dispiaciuti i ménage à trois. Quando stavo con Simone de Beauvoir, il nostro amore si poteva definire “amore aperto”, rivoluzionario per quei tempi. Il nostro era un amore necessario, ci conveniva conoscere anche degli amori contingenti, quelli occasionali di sesso femminile, amanti di Simone che era bisessuale. Fui ritenuto un immorale, perfino pederasta. Soltanto quando avremo cominciato a sbarazzarci del tabù dell’incesto (tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle), avremo raggiunto la totale libertà. Quel che conta è l’intenzione. L’uomo non è niente altro che quello che progetta di essere; egli non esiste che nella misura in cui si pone in atto; non è, dunque, niente altro che la somma dei suoi atti, niente altro che la sua vita. Da questo possiamo comprendere perché la nostra dottrina faccia orrore a un certo numero di persone. Perché, spesso, esse hanno un solo modo di sopportare la loro miseria, ed è di pensare: le circostanze sono state contro di me, io volevo molto di più di quello che sono stato. Non sento di essere il prodotto del caso, un granello di polvere nell’universo, ma qualcuno che era aspettato, preparato, prefigurato. In breve, un essere che solo un Creatore potrebbe mettere qui. E questa idea di una mano creatrice si riferisce a Dio, anche se si tratta di un Dio assente, che è più grande del Dio presente.
Che era ateo lo si sapeva…
Sì, però è molto scomodo che Dio non esista, poiché con Dio svanisce ogni possibilità di ritrovare dei valori in un cielo intelligibile; non può esserci un bene a priori poiché non c’è nessuna coscienza infinita e perfetta per pensarlo. Tuttavia l’uomo non è diventato ateo. Il silenzio del trascendente, congiunto al perdurare, nell’uomo moderno, instaura l’assenza di una esigenza religiosa. Avevo bisogno di Dio, mi fu dato, lo ricevetti senza capire che lo cercavo. Non potendo attecchire nel mio cuore, egli ha vegetato in me, poi è morto. Oggi, quando mi si parla di Lui, dico con quel tanto di divertito, senza una punta di rimpianto, nel modo in cui un vecchio, vagheggiando, si rivolge a una vecchia fiamma incontrata per caso: «Cinquant’anni fa, senza quel malinteso, senza quell’errore, senza quell’incidente che ci separò, avrebbe potuto esserci qualcosa fra noi». Ho perduto la fede completamente verso gli undici anni, o piuttosto mi sono accorto che l’avevo perduta: ero a La Rochelle, attendevo due amichette con cui prendevo il tram per andare al liceo, e per distrarmi mi sono detto: “Toh, Dio non esiste”. È caduto in questo modo e non è mai ritornato. Ed era nei fatti una presa di coscienza di ciò che avevo concepito prima.
Tra i suoi viaggi c’è stato anche uno a Napoli. Ci racconti.
A Napoli ho scoperto l’immonda parentela tra l’amore e il cibo. Non è avvenuto all’improvviso, Napoli non si rivela immediatamente: è una città che si vergogna di se stessa; tenta di far credere agli stranieri che è popolata di casinò, ville e palazzi. Sono arrivato via mare, un mattino di settembre, ed essa mi ha accolto da lontano con dei bagliori scialbi; ho passeggiato tutto il giorno lungo le sue strade diritte e larghe, la Via Umberto, la Via Garibaldi e non ho saputo scorgere, dietro i belletti, le piaghe sospette che esse si portano ai fianchi. Verso sera ero capitato alla terrazza del caffè Gambrinus, davanti a una granita che guardavo malinconicamente mentre si scioglieva nella sua coppa di smalto. Ero piuttosto scoraggiato, non avevo afferrato a volo che piccoli fatti multicolori, dei coriandoli. Mi domandavo: «Ma sono a Napoli? Napoli esiste?
Abbiamo capito: Napoli non le è piaciuta. Poco importa: Napoli non deve piacere a tutti, deve piacere soprattutto ai napoletani!