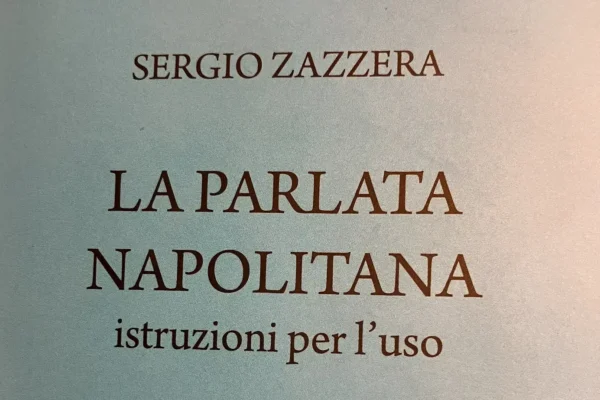Oggi ci è venuto a trovare il fantasma di Emilio Villa (Affori 1914 – Rieti 2003): parliamo di avanguardia. Studioso, poeta, scrittore, traduttore della Bibbia e dell’Odissea, artista, conoscitore profondo di lingue antiche, del greco, del latino, nella poesia italiana del Secondo Novecento, l’opera di Emilio Villa è certamente tra quelle che hanno dato un maggior contributo alla formazione della “tradizione del nuovo”, che la recente lettura di critici illustri (Aldo Tagliaferri, Cecilia Bello Minciacci, Francesco Muzzioli, etc.) solo in parte hanno condotto verso una considerazione più consona al suo reale valore. Con un principio di base radicalmente invertito rispetto al circolo vizioso di una cultura ridotta a mero consumo, i testi villiani, pieni di francesizzazioni, latinizzazioni e dialettizzazioni, si aprono, atipici, al divenire della parola, alla provvisorietà, a una non-poesia, a dismisura, a un’utopia depotenziata che si sposta verso un campo asemantico, oltre la pagina scritta, per farsi altro, libro-oggetto, azione poietica.

Il mondo villiano è abitato da numerose personalità, da amici pittori-poeti coi quali s’imbarca verso lidi – e non verso “il mare aperto” – da esplorare e conquistare. Per anni, dunque, Emilio Villa è stato rimosso dalla critica ufficiale, “privato” al grande pubblico, complice lo stesso poeta, “troppo riservato”, secondo alcuni emeriti critici, che ci pare un alibi nemmeno tanto accorto, visto che quando hanno avuto la possibilità di poterlo “leggere”, l’unica azione che sono riusciti a produrre è stato un fuggi-fuggi generale. Chi si imbatte in Emilio Villa, si troverà di fronte un’ipertrofica energia linguistica, ritmo incessante di assonanze e dissonanze, scardinamenti di incrostazioni marce della nostra lingua, che ogni fruitore di letteratura dovrebbe tener da conto: uno strumento strutturale, extraverbale, lontano da moderatismi, cameratismi, finalità speculative, da un disagio profondo di una liricità in comunicativa.

Infatti, Villa non apparteneva a nessuna corrente o gruppo (rifiutò di par parte della neoavanguardia del “Gruppo 63”, ma ne influenzò il linguaggio). In un tempo ripetitivo e divagante, la poesia villiana sceglie la via dell’allegoria, del desueto, di un puntiglioso recupero del nonsense, del presente/non presente, che gli permettono di confluire i detriti linguistici, l’omofonia e l’enigmaticità, passando per una glossolalìa maxime, nel regno del Nulla, dell’Origine, con una raffinata eloquenza antifrastica. Corre lungo l’asse dei tempi e delle “lingue morte” per approdare a un niente primordiale, acerbo quanto ingegnoso, al di là di ogni canone, resistente a qualsiasi ragione del metodo teorico, in quanto non vi è metodo che determini o giustifichi questa o quella struttura poematica e pretendere di affrancarsi dal continuo movimento delle incertezze.
Maestro, in poche parole: come definirebbe la sua poesia?
La mia poesia si basa su una lingua prolifera che, dilatandosi in più direzioni, ritrova il gusto dell’azzardo, lo spirito anarchico e del rischio.
Con la complicità della storia. Cosa ha da dire contro la storia?
La Storia è una grande ambizione umana, come intento primario sublimare la realtà in una dimensione assoluta, neutra, pacifica. La storia è uno sbaglio continuo, che non si ferma, e non si stanca mai di sbagliare, di rifare, di rivedere, di ricredersi, di affermare oggi, per rimangiarsi tutto domani.
Maestro, ma senza storia l’uomo è senza memoria.
D’accordo, ma la storia ha una pregiudiziale contro le motivazioni d’avanguardia, affossa qualsiasi ricerca, il tentativo di trovare nella parola stessa un nocciolo estraneo a ogni economia cronologica. Vedi, amico mio, la mia scrittura iper-sperimentale non vuole comunicare niente se non l’incomunicabilità, la “dannazione al fallimento” che ogni scrittura racchiude in sé.
L’aspetto che emerge quando un cultore si avvicina alla sua poesia, è l’ostracismo della stragrande maggioranza di critici nei confronti del suo linguaggio alternativo a quello tradizionale, collocandolo in un tempo astorico. Cosa ha da dire a questi critici?

Per prima cosa i miei testi sono di natura temporali: cosa di cosa, cosa, cosa della cosa | perché solo solo i minuti scadono | in un tempo così industriale | la via cede, la gita non si fa, son morte le siepi, | le schiene sudorate, che bara, che baraonda, | che bara, che onda, che cara, che tonda. I miei critici hanno sempre vissuto in un mondo “appartato” e criptico, per il timore di non capirci niente. Si sono autoproclamati depositari del mio verbo pur consapevoli che non sarebbero riusciti a capirci qualcosa.
La sua poesia d’avanguardia mi sembra molto differente da quella della neoavanguardia dei “novissimi”. In che si differenzia?
L’avanguardia che pratico (anche se non mi piace questo termine: preferisco “scrittura alternativa”) è una poetica in apnea, di grosso respiro, spinta da una dicotomia degli estremi: dentro/fuori; origini/non origini; scrittura/non scrittura. Quella dei “novissimi” è soprattutto politica, legata alle circostanze della società che crede di modificare operando dall’interno (ma il risultato era scontato: è stato fagocitata dalla grande industria culturale, vedi Feltrinelli, per poterla manovrare, con la prospettiva di far bella mostra in un muse). Io mi tengo lontano da questi giochi di potere, muovendomi in piena libertà in base al flusso della parola: «… il mare possedeva corpo e capo. | le immagini erano il silenzio | inquinato. le figure erano la polpa | dell’invisibile. e le labbra | forti come le scapole e le mascelle.| […] il linguaggio erano le stagioni | estreme, non eliminate…».