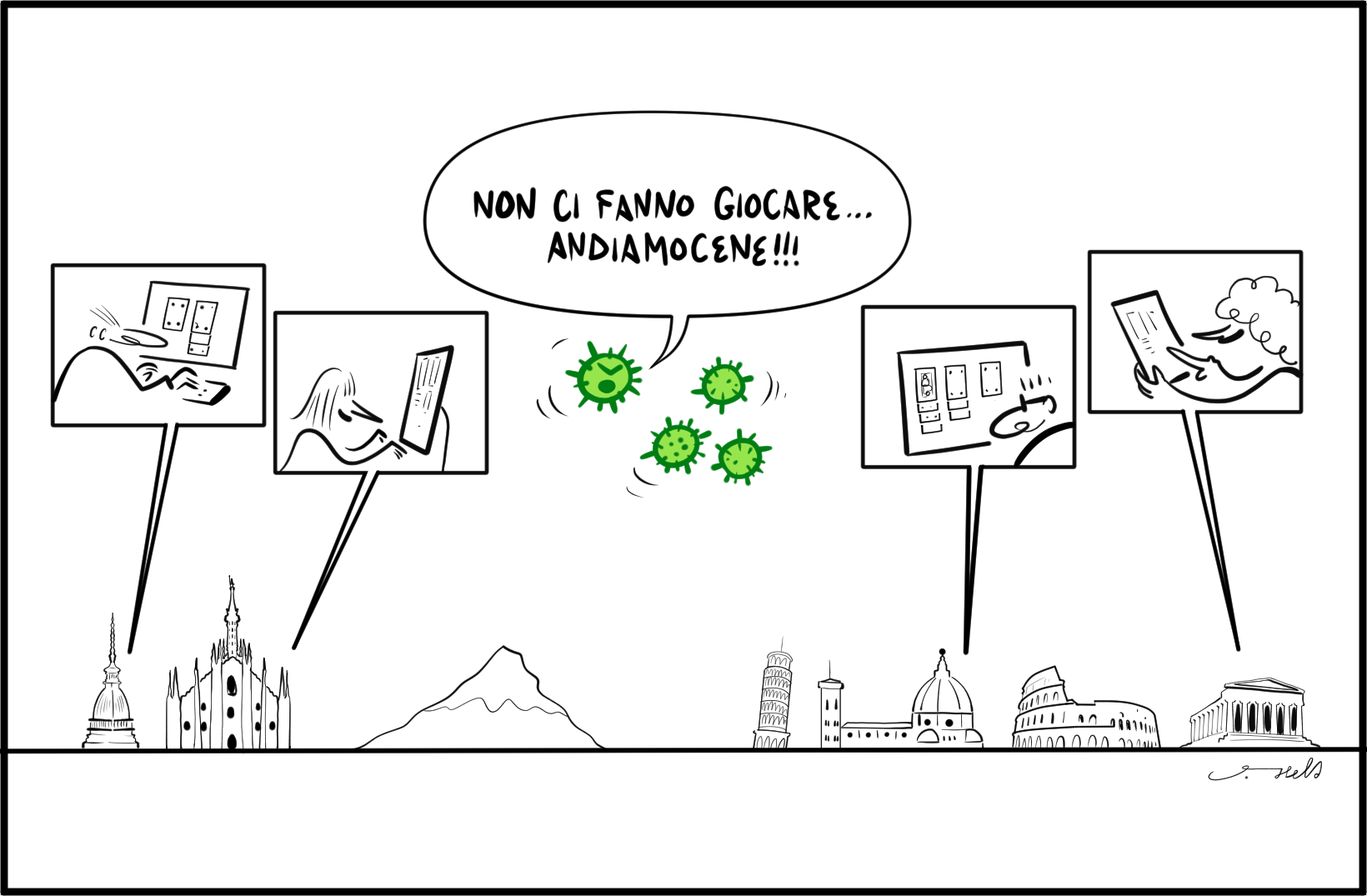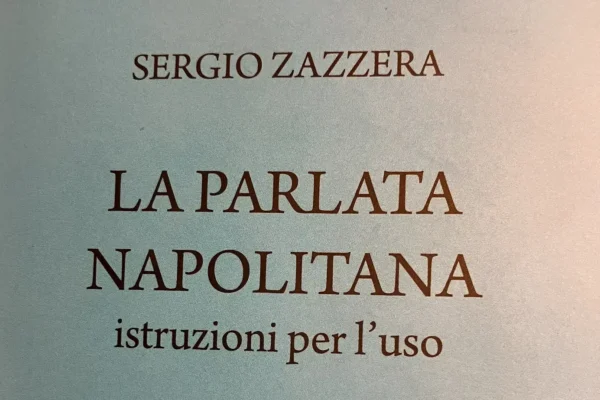Oggi ci è venuto a trovare il fantasma del filosofo Blaise Pascal, matematico, fisico, filosofo e teologo francese. Nacque a Clermont-Ferrand nel 1623 e morì 1662 dopo una lunga malattia che si portava dietro sin da bambino.
Fu un bambino prodigio, dedito inizialmente alle scienze naturali e alle scienze applicate, ma contribuì, in seguito, in modo significativo, alla costruzione di calcolatori meccanici e allo studio dei fluidi. Ancora adolescente scrisse un trattato di geometria proiettiva e collaborò con Pierre de Fermat sulla teoria delle probabilità che è alla base delle moderne teorie economiche e scienze sociali. Dopo un incidente che mise a repentaglio la sua vita, ebbe una conversione mistica che lo allontanò dalla matematica e dalla fisica per dedicarsi alle riflessioni religiose e filosofiche. Ha scritto numerosi volumi: Saggio sulle coniche, 1642; Nuove esperienze riguardanti il vuoto, 1647; Prefazione sul trattato della vita, 1651; Il triangolo aritmetico, 1654; Memoriale, 1654; Le lettere provinciali, 1656-1657; Dello spirito di geometria, 1657; Elementi di geometria, 1657; L’arte di persuadere, 1657; Dell’equilibrio dei liquidi, 1663; Della pesantezza dell’aria, 1663; Pensieri, 1670 (postumo).
Voltaire afferma che il tesoro più prezioso dell’uomo è la speranza che mitiga i nostri dolori e ci prospetta piaceri futuri nel momento in cui siamo in possesso di piaceri presenti. Se gli uomini fossero tanto sventurati da occuparsi soltanto del presente, non si seminerebbe, non si costruirebbe, non si pianterebbe nulla, non si provvederebbe a nulla; si sarebbe privi di tutto in mezzo a questa falsa gioia. Allora vivere nel presente non giova all’umanità?
Noi non viviamo mai nel presente. Anticipiamo il futuro, troppo lento ad arrivare, come per affrettarne il corso, o ricordiamo il passato, troppo rapido nel passare, come per fermarlo. Vaghiamo, imprudenti, in tempi che non ci appartengono e non pensiamo affatto al solo che ci appartiene; vanamente fuggiamo l’unico tempo che abbia realtà. È che il presente per lo più ci ferisce. Lo nascondiamo alla nostra vista perché ci fa star male e se è piacevole è allora spiacevole vederlo passare.
Leopardi affermava che l’uomo nasce già infelice, il primo vagito che emette può definirsi quale rassegnazione nei confronti di una natura matrigna. Ma, secondo lei, perché l’uomo è infelice?
 Ho scoperto che tutta l’infelicità degli uomini proviene da una cosa sola: dal non saper restare tranquilli in una camera. Ho voluto scoprirne la ragione, ho scoperto che ce n’è una effettiva, che consiste nella infelicità naturale della nostra condizione, debole, mortale e così miserabile che nulla ci può consolare quando la consideriamo seriamente.
Ho scoperto che tutta l’infelicità degli uomini proviene da una cosa sola: dal non saper restare tranquilli in una camera. Ho voluto scoprirne la ragione, ho scoperto che ce n’è una effettiva, che consiste nella infelicità naturale della nostra condizione, debole, mortale e così miserabile che nulla ci può consolare quando la consideriamo seriamente.
È risaputo che l’uomo quando è infelice tende a dimenticare, magari affidandosi al divertimento, ad un sorriso. Perché considera il divertimento una miseria?
Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l’ignoranza, hanno deciso di non pensarci per rendersi felici. L’unica cosa che ci consola dalle nostre miserie è il divertimento, e intanto questa è la maggiore tra le nostre miserie. Nel divertimento ci si allontana da Dio.
Perché la ragione non riesce ad esercitare il potere sull’amore, sui sentimenti di cuore?
Perché la ragione non conosce le ragioni del cuore. Il cuore ha le sue prigioni che l’intelligenza non apre. Tutta l’infelicità dell’uomo deriva proprio da questa sottomissione, dalla sua incapacità di starsene nella sua stanza da solo. Chi crede di essere immune da questa dipendenza, è in contraddizione, è indice di falsità. Il primo effetto dell’amore è di ispirare un gran rispetto: si ha una sorte di venerazione per ciò che si ama. È giustissimo: non si vede nulla nel mondo di così grande come ciò che si ama.
Si ha l’impressione di sentirsi soli anche tra la gente. Come se lo spiega se l’uomo è nato per dialogare con i propri simili?
Perché l’uomo è sempre in balia dell’incertezza, spinto da un estremo all’altro, sente la sua nullità, la sua disperazione, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua debolezza e salgono immediatamente dal profondo del suo cuore la noia, la melanconia, la tristezza, il cattivo umore, l’irritazione, la disperazione.
Ma l’uomo ha la ragione per trovare ogni tipo di soluzione ai problemi esistenziali che l’assillano. Perché è impedito in questo?
Perché l’uomo non agisce affatto secondo ragione, che pure è il suo modo di essere, agisce col cuore ed è la sua rovina. Le nostre paure ingrandisce così tanto il tempo presente, che facciamo dell’eternità un niente, e del niente un’eternità.
Come può, uno scienziato come lei, che è stato abituato a confutare i vari fenomeni con razionalità attraverso dimostrazioni pratiche, un giorno diventare un mistico e credere in Dio? Qual è stata la motivazione che le ha fatto cambiare idea sulla ragione in favore di una conversione apologetica?
Ho perso tanto tempo a spiegare la “pittura dell’uomo”, cioè la descrizione della sua natura e della sua condizione esistenziale senza trovare risposte, ma solo miseria e debolezze, pochezza e fragilità come un “ridicolo eroe” senza arte né parte, che mi ha convinto che l’unica possibilità di salvezza dell’uomo dalla morte, ma anche dalle tragedie della disperazione è rappresentata dalla fede in Cristo.
Una domanda specifica sulla religione è doverosa a questo punto. Partiamo dalla dichiarazione di Feuerbach, “l’ateismo è il segreto di ogni religione”, che non esclude la presenza dell’Assoluto, cioè di Dio, ma lo mette da parte per sostituirlo con l’uomo come Unico, che è sempre un’affermazione che parla di Dio, come addirittura troviamo nel pensiero di Sade. Può l’ateismo costituire un rapporto di trascendenza come quello teologico?

Direi di sì, dal momento che la grandezza dell’uomo sta nel fatto che egli si riconosce miserabile, mentre un albero non si riconosce miserabile; ed essendo una creatura pensante cerca in qualche modo di riscattarsi dalla propria infermità e impotenza fisica. E questa consapevolezza delle proprie miserie non esclude nell’ateo di sottostare a delle leggi più grandi di lui, le stesse leggi di un teologo.
Come ben sa, Voltaire ha criticato i suoi Pensieri, accusandolo di accanirsi e dipingere gli uomini tutti cattivi e infelici, dicendo eloquentemente delle ingiurie al genere umano. Secondo Voltaire non siamo né così cattivi né così infelici come dice lei. Cosa ha da dire a Voltaire e a tutti noi?
Agli uomini non s’insegna ad essere galantuomini, e s’insegna loro tutto il resto; ed essi non si piccano mai tanto di sapere alcunché del resto, come essere galantuomini. Non si piccano di sapere se non la sola cosa che non viene loro insegnata: la falsità. È così che scorre tutta la vita. Si cerca il riposo combattendo certi ostacoli; e, superati, il riposo diviene insopportabile, perché o si pensa alle miserie che si hanno o a quelle che ci minacciano: l’antidoto non è che la cattiveria, che è una forma di difesa, riempiendo l’animo col suo veleno. Da qui l’infelicità dell’uomo, che si annoierebbe anche senza causa alcuna di noia.
Allora, secondo lei, per vincere la cattiveria, l’infelicità, basta divertirsi?
L’uomo, per quanto sia pieno di tristezza, se si può ottenere da lui di farlo partecipare a qualche divertimento, eccolo felice per tutto quel tempo. E l’uomo, per quanto felice sia, se non è divertito e occupato da qualche passione o da qualche piacevole distrazione che impedisca alla noia di dilagare, sarà in beve triste e infelice. Senza divertimento non c’è gioia, e col divertimento non c’è tristezza. Se la nostra condizione fosse veramente felice, non occorrerebbe distoglierci dal pensarvi, per renderci felici.
Ma è così ridicolo l’uomo secondo il suo pensiero? Come definirebbe un uomo, l’umanità intera?
Un nulla in confronto all’infinito…
Ma questo lo sappiamo già!
Un tutto in confronto al nulla, un qualcosa di mezzo fra nulla e tutto. Infinitamente lontano dal poter comprendere gli estremi, la fine delle cose e il loro principio sono invincibilmente legati in un segreto impenetrabile per lui, che è ugualmente incapace di scorgere il nulla da cui egli è tratto e l’infinito da cui è inghiottito.

Mi scusi, ma credo che lei sia in evidente contraddizione. Come può un uomo incapace di scorgere il nulla e inerme di fronte all’infinito, credere in qualcosa che, se non è nulla è comunque infinita come la fede?
Non conviene far niente che per il certo, lo stesso niente si dovrebbe fare per la fede: infatti, essa non è fornita di certezza. Ma quante cose non si fanno per l’incerto, come una scommessa, una previsione, un’intuizione! Io dico allora che non bisognerebbe fare niente del tutto, perché niente è certo; e che c’è più certezza nella fede che non l’affermare che noi vedremo la giornata di domani: non è certo infatti che noi vedremo il domani, ma è certamente possibile che noi non lo vediamo, punto. Ma ci crediamo lo stesso al domani. Tutto al mondo si muove per l’incerto, o si lavora per l’incerto, docet Sant’Agostino. Allora perché da questa regola lasciamo fuori l’incertezza della fede. Come il domani non è confutabile, ma ci crediamo, così deve valere per la fede.
Sembra che la vita si possa solo descriverla per negativi e il divertissement è il perpetuo alibi di una esistenza ambigua che si serve delle contraddizioni per eludere i problemi e rimane indecisa in una quiete irrequieta. È questo il confuso quotidiano. Sembra occupare tutta la vita, è senza limiti e pone un marchio di irrealtà su ogni altra vita. Quanto è vera, secondo lei, questa affermazione di Maurice Blanchot?
Perché noi desideriamo la verità e non troviamo che incertezza; cerchiamo la felicità e non troviamo che miseria e morte. Insomma, siamo incapaci della certezza e della felicità. Questo desiderio ci è lasciato sia per punirci, sia per farci sentire caduti in un baratro senza uscita se non attraverso l’affermazione e la consapevolezza di una essenza irreale, dal momento in cui abbiamo sostituito la fede con il bene materiale, l’amore con la cattiveria. Invano l’uomo cerca di colmare il vuoto, cioè l’irreale, con tutto ciò che lo circonda. Nessuna cosa può dargli, però, neanche il divertissement, la soddisfazione di sentirsi pieno; nessun oggetto o sentimento ne sono capaci perché appartengono all’abisso infinito dell’umanità, e come avviene in fisica, non può essere che colmato da una forza uguale e contraria, cioè da un altro oggetto e/o sentimento infinito e immutabile, cioè da Dio.
Comunque ci si trova continuamente delusi.
Quando si vogliono portare le virtù fino agli estremi, nel grande e nel piccolo, si presentano dei vizi che s’insinuano in esse inavvertitamente, procedendo per vie impercettibili, dalla parte del piccolo infinito, in modo che ci si perde nei vizi e non si vedono le virtù. Ci s’inganna nella perfezione stessa, il che spiega la ricerca dell’Altro, lasciandosi precipitare nell’Altro. Ciò denota almeno la sopravvivenza dell’agilità dell’anima, visto che quella fisica non sa opporsi ai vizi.
Ma come la mettiamo se il pensiero costituisce la grandezza dell’uomo, tutta la sua dignità?
Come la mettiamo! Il pensiero è aspirare all’ignoto, ma da solo non riesce neanche ad avvicinarsi. Dunque non determina nulla. Il mondo va avanti da sempre con la promessa di materializzare l’ignoto, al punto da dichiarare la morte di Dio. Fare a meno di Dio equivale a negare l’ignoto, cioè la nostra stessa esistenza.
Se non si hanno certezze comuni come si possono avere certezze straordinarie, divine?
Ai posteri l’ardua sentenza.