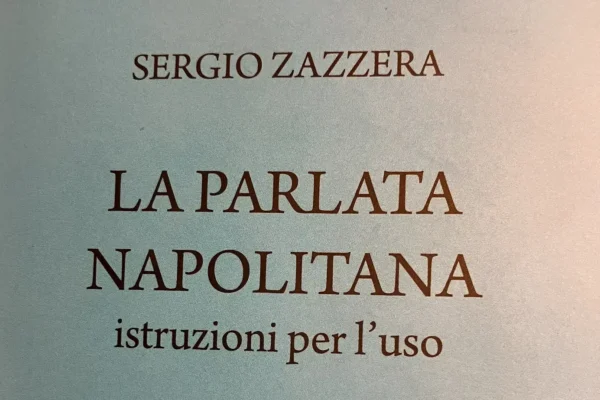Oggi ci è venuto a trovare il fantasma di Adriano Spatola, uno dei più importanti poeti del Novecento e promotore della “poesia totale”, definita nel volume Verso la poesia totale. Nasce a Sapjane (Istria) nel 1941 e muore a Sant’Ilario d’Enza (RE) nel 1988. Nel 1957 si trasferisce a Bologna dove collabora alla rivista «Il Mulino» e successivamente conosce all’Università L. Anceschi che lo fa collaborare al «Verri». Pubblica la sua prima plaquette di poesie, Le pietre e gli dei, nel 1961. Nel capoluogo emiliano fonda la sua prima rivista, «Bab Ilu», in collaborazione con altri, di cui è stato l’animatore più accanito. Ha pubblicato, oltre al romanzo L’Oblò (1964), diversi volumi di poesie lineari, visuali e concrete, saggi. Ad una esposizione di poesia visuale e concreta del ’65, per la prima volta usa il termine zeroglifico. Nel ’67 si trasferisce a Roma a dirigere la rivista «Quindici», dove conosce G. Niccolai, che diventa la sua compagna dopo la separazione dalla moglie. Nel ’79 fonda e dirige  «Baobab»(la prima audiorivista di poesia sonora in Italia) e nel 1981 «Cervo Volante».
«Baobab»(la prima audiorivista di poesia sonora in Italia) e nel 1981 «Cervo Volante».
Pierre Garnier sostiene che «la lingua non è più un codice per comunicare, ma una materia a cui bisogna dar vita». Quindi anche la poesia lineare appartiene ad un progetto poetico “totalizzante”?
La nuova poesia prende l’avvio, nel suo processo di formazione, dai linguaggi tipici di altre arti, in particolare delle arti plastiche, per farsi «oggetto» che rifiuta la lettura.
Nella sua ricerca artistica hanno trovato un posto rilevante gli “zeroglifici”, una poesia che si fa segno. Come è arrivato alla sua realizzazione?
Ho sempre avuto la passione per le scritture antiche sin dal ginnasio, e in particolare per i geroglifici che mi spinse allo studio dell’antica poesia egizia, anche perché si stava facendo strada in me la convinzione che l’aspetto figurale della poesia ha un’importanza fondamentale. Sul piano creativo, la convinzione si materializza dal fatto che la poesia cerca oggi di farsi medium totale, di sfuggire a ogni limitazione, di inglobare teatro, fotografia, musica, pittura, arte tipografica, tecniche cinematografiche e ogni altro aspetto della cultura, in un’aspirazione utopistica al ritorno alle origini.
Non crede che i suoi zeroglifici racchiudano in sé un’ambiguità, in quanto ad ogni montaggio-smontaggio si stratificano diversi piani di lettura non sempre palesi?
Ma è proprio questo il momento costruttivo. Questo coinvolgimento sull’ambiguità è essenziale, e come diceva il mio amico Franz Mon, l’ambiguità è la reale concretezza della poesia e ogni identificazione vale una sparizione. Una vitalità stimolante di processo di decodificazione che si trasforma in energia creativa.
È ancora valida nella nostra realtà una proposta di poesia totale, dove non si riesce neanche più a definire la semplice poesia lineare?
La poesia totale sembra offrire oggi al lettore non un prodotto definitivo, da accettare o subire nella sua chiusa perfezione, ma gli strumenti stessi della creazione poetica, nella loro strutturale rimaneggi abilità.
Rispetto al suo periodo, oggi si tende a dividere le varie discipline artistiche, probabilmente per occupare più terreno da gestire e blindarle per garantirsi “acqua al proprio mulino”. Cosa ci dice in merito?
Ciò che contraddistingue la nostra epoca non è più soltanto il sistema della divisione delle competenze, conseguenza di un’ignoranza galoppante, ma anche l’aspirazione a un mondo  nel quale ogni differenza culturale tra l’artista e il non artista, tra l’intellettuale e il suo pubblico possa definitivamente scomparire.
nel quale ogni differenza culturale tra l’artista e il non artista, tra l’intellettuale e il suo pubblico possa definitivamente scomparire.
Ci spiega come nasce la voglia di manipolazione dei segni nella poesia d’avanguardia?
Posso parlare per me. Per quanto mi riguarda la manipolazione dei segni è di rimettere in questione le parole – e attraverso le parole – una filosofia del mondo. D’altronde ci sono scrittori che le abitudini linguistiche di un’epoca costringono a rifare il mondo, e che vivono in un tale perenne stato di soffocamento, che non sanno reagire se non portando alle estreme conseguenze i contenuti e le forme di un apparato verbale.Per scrittori di questo genere, la realtà non è un dato di fatto limpidamente osservabile, ma un insieme di voci dissonanti che gridano contemporaneamente nel deserto.
Più volte lei ricorre al termine iperspazio da opporre al presente precostituito, alle istituzioni cieche e sorde verso i problemi della gente, al dato ormai in disuso. Sembra un linguaggio anarchico il suo. Come si giustifica?
Perché dovrei giustificarmi? Si devono giustificare coloro che hanno ridotto la letteratura ad un luogo comune, prevedibile e senza spinta innovativa. La poesia di ricerca, di cui mi  reputo un asservitore, vuole rifare il mondo, creare in laboratorio il linguaggio del mondo in concorrenza col mondo, nel rifiuto della pura e semplice registrazione lessicale.
reputo un asservitore, vuole rifare il mondo, creare in laboratorio il linguaggio del mondo in concorrenza col mondo, nel rifiuto della pura e semplice registrazione lessicale.
Un’ultima domanda: esiste ancora la poesia?
Oggi la poesia è nello stesso tempo qualcosa di troppo complicato e di troppo elementare. In entrambi i casi si tratta di qualcosa che sembra rifiutare ogni interpretazione. Ma perché un poeta deve per forza proporre un’interpretazione della poesia? Le interpretazioni sono sempre interessate, legate a un momento particolare. Per la società la poesia è qualcosa che la riguarda sempre di meno. La società fa a meno della poesia proprio nella misura in cui ne garantisce l’esistenza. Credo che la sua domanda dovrebbe essere riformulata in questo senso: cosa sta diventando la poesia? Nell’incertezza il poeta si sente il dovere di assumere su di sé a tutti i costi il ruolo di manipolatore di fantasmi. In questo senso la poesia può benissimo servire a verificare tanto un sogno quanto un’esigenza di verità o un progetto di viaggio.