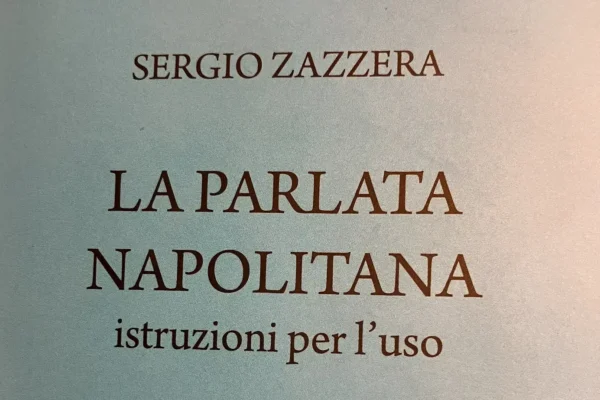Oggi ci è venuto a trovare il fantasma di Achille Campanile, lo sceneggiatore di Miseria e nobiltà, con Totò protagonista. Parliamo di umorismo. Campanile nasce a Roma nel 1899. Nel 1920 inizia la carriera di giornalista presso «L’idea Nazionale», diretta da Enrico Corradini. Dal 1925 si dedica al romanzo pubblicando nel 1927 uno dei suoi più importanti romanzi: Ma che cosa è quest’amore? Al cinema arriva nel 1937 lavorando al soggetto del secondo film di Totò di cui scrive la sceneggiatura insieme a suo padre. Morì nel 1977 a Lariano, nei pressi di Velletri.
Lei è un riconosciuto umorista. Ma chi è un umorista?
L’umorista è uno che istintivamente sente il ridicolo dei luoghi comuni e perciò è tratto a fare l’opposto di quello che fanno gli altri. Perciò può essere benissimo in hilaritate tristis e in tristitia hilaris, ma se uno si aspetta che lo sia, egli se è un umorista, può arrivare perfino all’assurdo di essere come tutti gli altri “In hilaritate hilaris e in tristitia tristis” perché, e questo è il punto, l’umorista è uno che fa il comodo proprio: è triste o allegro quando gli va di esserlo e perciò financo triste nelle circostanze tristi e lieto nelle liete.

Quando si è reso conto di avere una vena umoristica?
Un giorno, avendo bisogno di quattrini, mi presentai allo sportello di una banca e dissi al cassiere: “Per favore, mi potrebbe prestare centomila lire?”. Il cassiere mi disse: “Ma sa che lei è un umorista”. Così scopersi di esserlo.
Ma lei si sente un umorista?
Personalmente non mi sono mai sentito un umorista. È un’etichetta restrittiva, limitativa, che non mi piace. Sono uno scrittore e basta, senza aggettivi. La mia visione umoristica della vita non è voluta. Il mio umorismo, se di umorismo vogliamo parlare, lo trovo nelle cose. Per dirla con Dante: ho sempre scritto “come dentro detta”. Ma che cosa è questo amore? io lo scrissi molto seriamente. Furono poi gli altri a dire che faceva divertire, non solo, ma che conteneva molte cose nuove, una specie di sasso buttato nello stagno della nostra letteratura. Lo spirito del libro nacque spontaneamente.
Ennio Flaiano afferma che l’umorismo serve a mascherare contenuti polemici nei confronti di autorità costituite e figure dominanti. Oppure renderli espliciti, e in tal caso il riso diventa satira, cioè comicità con cui si aggrediscono i nemici della cultura, società, morale, politica. Walter Benjamin, invece, conferma che per il pensiero non c’è partenza migliore del riso. Ma chi è l’umorista?
L’umorista è uno che fa il solletico al cervello.
Lei è stato anche un drammaturgo. Da più parti si dice che il teatro è in crisi. Cosa ne pensa?
Io penso sempre alla crisi del teatro e mi scervello per trovare il mezzo per risolverla. Si può dire che non penso ad altro. Giorno e notte rifletto sulla difficile questione e consulto le opere dei nostri sommi, che si sono occupati di essa. Non già perché mi stiano tanto a cuore le sorti del teatro. Ma mi affatico per risolvere questa benedetta crisi nella speranza che, una volta risolta, non se ne parlerà più.
Nella sua lunga carriera di scrittore lei ha pubblicato un po’ di tutto. Come fa col romanzesco, dice Umberto Eco, così lei amplifica e poi distrugge il quotidiano. Ma ha dichiarato di sentirsi anche un poeta. Qual è la sua idea di poesia?
Bisogna intendersi su di essa. A me piace ciò che ha un contenuto poetico, una sostanza poetica. Ma la poesia formale, tradizionale, quella, per intenderci, basata su schemi classici, non mi piace. Specie quella francese (che del resto è la sola che posso leggere, dopo l’italiana). La trovo enfatica e faticosa, oltre che noiosa a leggersi: Mallarmé, Baudelaire, Verlaine. Non riesco a stare attento fino in fondo a un sonetto e quello che dice il poeta non m’interessa. Quando leggo una poesia, certe volte mi accorgo d’essere arrivato all’ultimo verso senza aver afferrato il senso, come se non avessi letto. Mi distraggo alle prime parole e vado avanti meccanicamente. Sarebbe possibile oggi leggere un poema? Omero, Virgilio, Dante.
Come nasce la sua scrittura?
Scrivo a mano, e quasi sempre su pezzi di carta avanzati o scampati all’altrui scrittura… Alla macchina da scrivere non m’è mai riuscito d’inventare, di comporre. La vedo nel bagaglio d’uno scrittore soltanto come utile strumento di trascrizione. Il suo ticchettio metallico mi distrae, la sua presenza fredda, meccanica, rappresenta un diaframma sempre difficilmente superabile tra me e il foglio di carta. Insomma mi è antipatica. Le mie cose le riscrivo parecchie volte, solo che le rifaccio sempre tali e quali. Se perdo qualche foglio lo riscrivo, ma quando poi lo ritrovo mi accorgo che non ho cambiato una sola virgola.

Spesso nelle sue opere si parla di morte.
Perché quasi tutto il grande umorismo ha spesso bisogno del dolore perché scatti la molla della comicità.
Ma che rapporto ha con la morte?
Quello di essermi fatto fregare!
Come tutti noi, d’altronde. Quali spunti prende da un evento così tragico?
Il contegno delle persone che seguono un funerale, per esempio: se fossero delle persone, così, che vanno a passeggio, non ci colpirebbe il loro modo di regolarsi. Ma siccome c’è il morto davanti, gli aspetti buffi ci colpiscono. Penso a certi disegni di Novello. Oppure penso a Joyce. Che comincia proprio anche con quell’uomo che va dietro ad un funerale e ha una saponetta in tasca che gli dà fastidio. Quando è seduto pensa sempre a questa saponetta mentre intorno si scambiano frasi di circostanza e dolenti strette di mano. Questo in generale. Poi io ho avuto grandi dolori personali, che si intrecciano alla vita di tutti i giorni e di tutti gli altri, così il contrasto tra cose buffe e tristezza mi è apparso sempre molto nitido.
Ci è sembrato, leggendo le sue opere, che lei non amasse molto il giornalismo. È così?
Tutta la mia vita è stata perseguitata dalla necessità di scrivere articoli, da quelle voci che ti telefonano di giorno e di notte, e ti chiedono tre cartelle, otto paginette, una cosa rapida, una cosa meditata. Tutti i viaggi che ho fatto nella mia vita sono stati rovinati dal fatto di dover poi scrivere un articolo.

Poi all’improvviso lascia la vita di città e si trasferisce in campagna. Come mai questo repentino cambiamento?
In primis per soddisfare un desiderio di mia moglie che desiderava un giorno vivere in campagna. Ci stabilimmo in contrada Arcioni, a pochi chilometri da Velletri. Comprai un casale da contadini del posto che sistemai rendendolo più ampio e comodo. La casa di Roma era diventata troppo piccola, la famiglia era cresciuta. Poi stavo al Babbuino, una strada molto trafficata, e quindi mi dava fastidio questo traffico eccessivo. Non si può lasciare la macchina un momento che arriva il vigile scrittore che sta sempre a ispirarsi sulle macchine e scrive, scrive, scrive.
E come si trovò a vivere in campagna, lei che era abituato al clamore di una grande città come Roma?
Non feci la vita di Cincinnato come avevo sperato trasferendomi in campagna, se è questo che vuole sapere. L’illusione durò un anno. Lo “sfizio” del vino prodotto in casa si rivelò subito più costoso di un hobby per miliardari. Feci i conti dopo la prima vendemmia e venne fuori che avrei risparmiato di più pasteggiando tutti i giorni a champagne. Anche il progetto “pollo ruspante” fallì, questo non per motivi economici ma per superiori ragioni umanitarie. I nostri polli, infatti, dopo un breve tirocinio da ruspanti nella vigna trovarono più confortevole proseguire la loro carriera in casa trasformandosi lentamente in “quasi parenti” e così si infranse definitivamente il sogno della vita agreste.
Oggi, mi creda, farebbe carte false per poterci vivere. Ma in un’altra vita, magari.