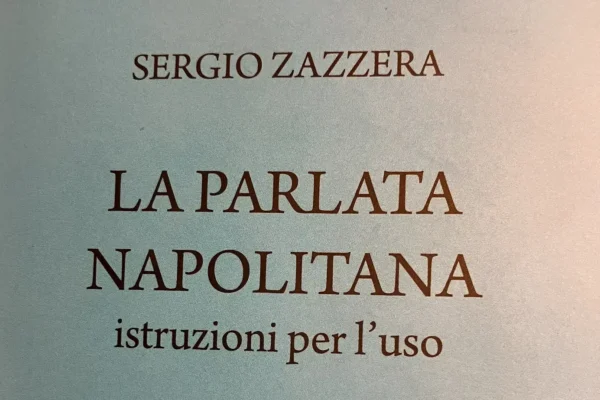Dopo i pronomi, ci tocca parlare dei verbi. E come nelle antiche grammatichette d’italiano, che ci piace tanto scimmiottare, parleremo innanzitutto dei due verbi ausiliari “essere” e “avere”.
Iniziamo da avé.
Rinunciamo alle tabelle dei vari tempi e modi, che si possono trovare in qualunque grammatica, anche su internet, e limitiamoci a porci solo qualche domanda.
Perché diciamo aggio e non ho?
Perché dal latino habeo è derivato in italiano haveo > havio > haio > hao > ho, mentre in napoletano si è mantenuta la forma originaria con la consueta modifica del suono bio (da beo) in ggio (come rabies > italiano “rabbia” e napoletano arraggia)
Per l’uso pratico, notiamo che il verbo avé in napoletano si usa solo come ausiliario, mentre “avere” nel senso di “possedere” si dice tené:
nun tengo sorde per “non ho soldi”
tengo famma per “ho fame “
Ma c’è un uso particolare di avé su cui vale la pena soffermarsi anche per qualche considerazione che esula dalla grammatica in senso stretto.
Noi diciamo che una cosa s’ha dda fà nel senso che “si deve fare”. Fin qui nulla da eccepire, perché la forma, anche se poco usata, c’è anche in italiano (chi non ricorda la celebre frase manzoniana “Questo matrimonio non s’ha da fare”?). La particolarità del napoletano però consiste nel fatto che all’espressione avé da (o avé ’a) non c’è alternativa, perché il verbo “dovere” da noi semplicemente non esiste (se non come sostantivo: Fa’ ’o duvere tujo).
Nell’ozio vacanziero agostano ci siamo chiesti, i miei amici ed io, quale potrebbe essere il motivo di una simile mancanza. I napoletani non hanno il senso del dovere? No, perché come abbiamo detto esiste la parola duvere come sostantivo. E allora?
Dopo lunga ed appassionata discussione, siamo giunti alla conclusione che la lingua mai come in questo caso riflette l’animus di chi la parla. E ci spieghiamo.
I napoletani sono stati purtroppo, come ormai tutti sappiamo, abituati ad essere dominati da popoli stranieri (superfluo fare la solita tiritera: greci, romani, barbari con qualche assaggio di cultura saracena, poi di seguito normanni, svevi, angioini, spagnoli, austriaci, ed infine – ci si lasci dire – piemontesi).
La necessità di orientare la propria vita in base ai voleri di altri deve aver prodotto in noi un senso di necessità, una radicata credenza nella ineluttabilità dello svolgersi della realtà oggettiva. Così non abbiamo sentito il bisogno di immettere nella nostra lingua il verbo della soggettività per eccellenza, “dovere”. E se ci obiettate che il verbo della soggettività per eccellenza è “volere” e non “dovere”, vi rispondiamo che volere non comporta automaticamente realizzare, mentre dovere implica un coinvolgimento totale della persona per il raggiungimento di un obiettivo. Voglio fà na cosa in napoletano è sentito quasi come “vorrei fare una cosa”; aggi’ ’a fà na cosa prelude invece alla realizzazione effettiva di quella “cosa”.
E mo ce n’âmm’ ’a jì â casa a magnà. Bona dummeneca.