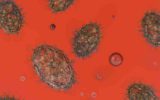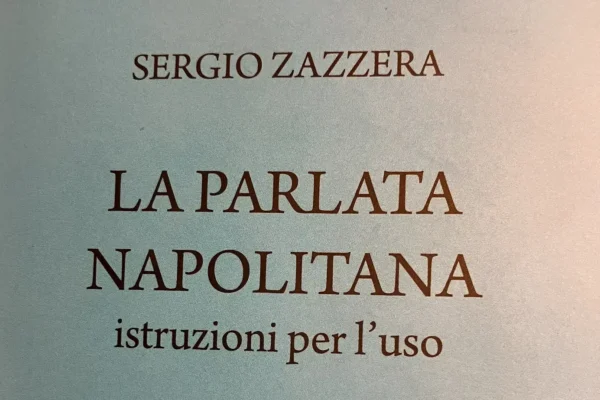Oggi parleremo di quella potente ed estremamente sintetica espressione del nostro spirito mordace, oramai poco usata ma a tutti nota, che è, per universale riconoscimento, il pernacchio.
Fin dall’antichità, come sappiamo, è stata riconosciuta ai popoli italici, specie dell’Italia meridionale, la tendenza allo sberleffo.
Ne è testimone il poeta Orazio (I sec. a.C.) che, riferendo una battuta di spirito fatta da un greco, dice che questo greco si cosparse appunto dell’italum acetum, lo spirito mordace delle genti nostrane, che aveva prodotto tipi di spettacoli improvvisati chiamati Fescennini e la farsa detta Atellana (perché fiorita ad Atella, città campana di cui resta il ricordo nel nome di un paese in provincia di Caserta, Orta di Atella).
Ecco perché riteniamo giusto trattare del pernacchio, anche se oggi, come accennavamo sopra, non esiste quasi più, confinato com’è a qualche vezzoso giochetto con bambini piccolissimi. Esso è sostituito già da tempo dal dito medio alzato, più silenzioso ma non meno caustico e forse più volgare, tanto che abbiamo avuto il dubbio, scrivendo questa lezioncina, di non incontrare l’interesse se non dei nostri coetanei.

Eppure il termine, già nella forma antica di vernacchio, ha un pedigree letterario di tutto rispetto. A parte le numerose volte che si trova adoperato nelle opere letterarie del nostro dialetto, lo troviamo anche nei titoli di due opere settecentesche: La violeieda spartuta ntra buffe e bernacchie del 1719 e Lo vernacchio, resposta a lo Dialetto napoletano (1780) del poeta e patriota della Repubblica Partenopea Luigi Serio, che polemizzava con Ferdinando Galiani, autore, appunto, dell’opera Del dialetto napoletano.
Anche se sapete già cos’è un pernacchio, ci piace ricordare la breve definizione che ne dà il D’Ascoli nel suo Dizionario etimologico napoletano: “scorreggia fatta con la bocca”.
Il termine deriva, com’è ormai acclarato, dal latino vernaculus “servile“, “da schiavo“, “degno di schiavo” (infatti il verna era lo schiavo nato in casa, da una schiava di casa).
Dire che un’azione era da schiavo per gli antichi, ovviamente, valeva dire che era un’azione volgare, triviale, degna di persone inferiori.
Anche il nostro “vernacolo”, che a volte usiamo come se fosse un termine più nobile di “dialetto”, aveva la stessa significazione di linguaggio basso, spregevole.
La P iniziale in luogo della V è piuttosto recente: fino all’Ottocento si trova la parola vernacchio e non pernacchio, e se il dizionario dell’Andreoli (1887) riporta anche il lemma pernacchio, rinvia poi a quello che all’autore sembrava ancora la forma più corretta, vernacchio, e solo lì c’è la definizione (“rumore fatto con la bocca in altrui dileggio”).
A riprova di quanto detto c’è ancora negli odierni dizionari (e forse nel ricordo di qualcuno di noi) il lemma vernia col significato di “sconcezza”, “boiata“, e per traslato “chiasso di bambini“. E infatti il sostantivo vernaculum indicava genericamente “azione scurrile”. L’azione scurrile poi si “specializzò”, venendo man mano ad indicare prima il peto (quello che per noi è ’o pireto, che deriva però da altra etimologia: peditum in latino è appunto la scorreggia) e poi il vero e proprio pernacchio.
Che ancora ai primi del Seicento vernacchio significasse “peto”, lo attesta la seguente battuta della Tabernaria, l’ultima commedia di Giambattista Della Porta (1535-1615), rappresentata ancora con successo nel 2005 al teatro Mercadante di Napoli con la regia di Renato Carpentieri:
“Aggio avuta na mala cacaressa, e lo cielo sa quanta vernacchie me songo scappate”.
Il pernacchio da noi è solo maschile (anche se, bisogna dirlo, qualche vocabolario riporta pernacchio e pernacchia come sinonimi). E il confronto, che si legge nell’Oro di Napoli di Giuseppe Marotta, fra il “maschio” pernacchio e la “molle e pigra” “pernacchia” (la tirata sull’argomento si può anche ascoltare nella bellissima recitazione di Eduardo De Filippo nel film che da quel libro trasse Vittorio De Sica nel 1954), è in effetti un confronto fra una parola nostrana e una italiana.
Sta di fatto che per noi il femminile è un epiteto per donna: è na pernacchia la donna che si dà arie di gran dama rivelandosi poi volgare nei modi o nell’animo.
Ed essere vestite da gran dama si dice essere mpernacchiate. In questo caso, però, ad essere onesti, il pernacchio funziona solo come deformatore (in senso, per dir così, espressionistico), operando su un verbo già esistente, l’italiano “impennacchiare” / “impennacchiarsi”, cioè “vestire in modo appariscente”. Il verbo infatti indicava originariamente l’adornarsi di un “pennacchio”, che in italiano indica fin dall’antichità il ciuffo di penne usato come abbellimento di un elmo o di un cappello e che usiamo anche in altra accezione quando citiamo il pennacchio del Vesuvio.
Pennacchio “originale” è invece quello di una famosa canzone:
“M’aggio accattato nu turbante, nu turbante â Rinascente, cu’ ’o pennacchio rosso e blu” (Caravàn petròl, 1958, di Nisa e Carosone).