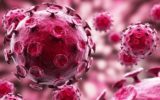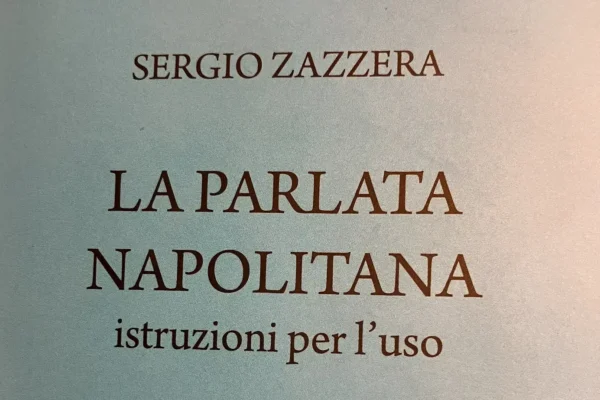A Napoli fare un liscebbusso a una persona significa redarguirla aspramente, farle “una lavata di capo”, meglio se con contorno di mazzate, cioè (come avvertiva già Enrico Malato) con un senso in più rispetto all’italico “rabbuffo”, potendo implicare anche un’azione …di mano.
In questo senso la parola è di facile lettura, dato che anche in italiano possiamo dire, con le stesse metafore, che si “liscia il pelo” a qualcuno (noi abbiamo la minaccia t’alliscio ’o pilo) oppure gli si danno delle “busse”.
D’altronde “bussare” (dal latino pulsare incrociatosi con (tam)burare “percuotere”) è anche italiano, e noi lo usiamo tuttora per “suonare alla porta” (picchiando l’uscio o pigiando il campanello), oltre che nella tipica espressione bussà a sorde, calcata nell’italiano “bussare a quattrini”, per “chiedere inopportunamente denaro”.
Ma il liscebbusso viene direttamente dal gioco delle carte, e precisamente da quel meraviglioso gioco d’intelligenza e di strategia che si chiama tressette. Nel tressette (e non solo a Napoli) si usa un gergo specifico, fatto di parole e gesti.
Uno dei gesti è quello che risponde alla parola lisciare, cioè strofinare sul tavolo una carta prima di giocarla (cioè di deporla sul tavolo perché sia messa a confronto con quelle che mettono gli altri tre giocatori, in modo che chi ha messo la carta più importante prende tutte e quattro).
Se liscio una carta, informo il mio compagno che ho altre carte di quel seme (so’ liscio a stu palo), e se la strisciata è più prolungata, gli dico che tengo ’a longa (“ho molte carte di questo seme”).
Altro segno è il bussare, cioè battere sul tavolo le nocche delle dita: vuol dire che si chiede al compagno di giocare la carta più alta che possiede di quel palo, e che è bene tornarci su nelle prossime giocate.
Naturalmente, se si fa un lungo striscio e contestualmente una bussata, il compagno che abbia in mano almeno due carte di quel seme delle quali una importante (sperabilmente il tre, detto ’a meglia) capisce che è assicurata in toto o quasi quella mano di gioco. Addirittura in questo caso si può fare “cappotto”, cioè lasciare gli avversari senza neanche un punto. Insomma dare una bella batosta! Ecco come deve essere avvenuto il passaggio dal gioco di carte alla vita quotidiana: ti faccio un liscebbusso, come dire “ti concio per le feste”. Nei dizionari napoletani di un secolo fa (lo notava anche il Malato) il termine liscebbusso non c’è. Ci sono però, e proprio come termini del tressette, liscio e bussare / bussata (e infatti anche nelle regole scritte da un tal Chitarrella nel ‘700 liscio e busso sono scritte separatamente).
Nei dizionari napoletani di un secolo fa (lo notava anche il Malato) il termine liscebbusso non c’è. Ci sono però, e proprio come termini del tressette, liscio e bussare / bussata (e infatti anche nelle regole scritte da un tal Chitarrella nel ‘700 liscio e busso sono scritte separatamente).
Se ne deduce che il termine liscebbusso, inteso nel senso di rimprovero, con o senza botte annesse, è di recente ingresso nel nostro dialetto, risalendo a non oltre i primi decenni del Novecento, anche se il tressette c’era già molto prima.
C’è poi un altro gesto che fanno i giocatori di carte, qualunque sia il gioco, anche se l’operazione cui stiamo per accennare si addice particolarmente al poker.
Quando si distribuiscono le carte, chi le riceve non le guarda subito, ma aspetta di averle tutte in mano e poi le scopre (a se stesso, ovviamente) un po’ per volta, quasi per gustarsi la sorpresa di quello che avrà. Quest’operazione, che ha qualcosa di scaramantico, noi indichiamo col verbo trezzià.
E infatti i nostri vocabolari recano trezzià, oltre che nel senso di “intrecciare” (da trezza “treccia”), anche in quello di “succhiellare”, termine italiano da noi poco usato nel senso indicato dal Devoto di “godersi qualcosa e in particolare scoprire a poco a poco le carte ricevute per il gioco allo scopo di godersi l’emozione della scoperta del punto avuto”.
Sennonché i dizionari della seconda metà dell’Ottocento non danno trezziare in quest’ultimo senso, e invece danno la forma terziare, da cui evidentemente è nato (con un fenomeno fonetico che i linguisti chiamano metatesi, cioè scambio, nel nostro caso scambio di posto fra la r e la e) trezzià, di cui ormai non riconosciamo più la vera origine.
Origine che è verosimilmente da cercare nello spagnolo terciar, che D’Ascoli dice significare “sbiecare, mettere di sbieco, disporre diagonalmente”: così infatti si dispongono le carte quando le trezziamo.
Secondo alcuni, poi, terciar affonderebbe le radici in un latino tertiare “ripetere per la terza volta” (forse trasportato nel gesto di chi, dopo aver scoperto la seconda carta dietro la prima, scopre la terza).
Ma il termine aveva, un secolo o un secolo e mezzo fa, un significato anche un po’ più ampio del nostro odierno trezzià. Citiamo testualmente dal dizionario di Andreoli (1888): terziare na primera “risicare, tentar cosa che può venirti così bene come male”, o anche “tirare un dado”. Insomma, col verbo si finì per indicare tutte quelle piccole operazioni che nel gioco consistono nello scoprire un esito, e quindi comportano anche una certa ansia. Se poi la cosa andava bene, si poteva terziare na bella primera, frase che passò a significare in genere “avere una buona ventura” ed anche “fare un bel trucco”. Si diceva poi anche terziare una persona, nel senso di “trovare uno che cerchi di cansarsi, chiapparlo, ripescarlo, coglierlo.” Insomma, che ci siamo persi con l’evoluzione della lingua!