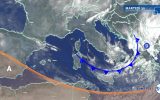Oggi si parla troppo e si pensa poco, cioè si parla per accumulo di intenzioni che non superano la sfera privata. In letteratura avviene la stessa cosa: accumuli di scritture per creare accumuli di libri che la maggior parte di noi non legge e non leggerà mai se si voglia evitare un voltastomaco. Walter Benjamin ci dice che «Uno dei compiti principali dell’arte è sempre stato quello di creare esigenze che al momento non è in grado di soddisfare». E allora Marco Furia, poeta genovese (1952, con una dozzina di volumi pubblicati), ci prova col suo volume Tratteggi (Anterem Edizioni/Cierre Grafica, 2017), fedele a Italo Calvino di «in questa predilezione per le forme brevi non faccio che seguire la vera vocazione della letteratura italiana», citazione riportata in epigrafe nel volume, invece di accumulare parole e frasi inutilmente sovrabbondanti, toglie quanto più possibile il superfluo riducendo i suoi scritti, piccolissimi racconti, a quasi dei frammenti che tendono all’essenzialità del discorso che non si svolge mai in prima persona:
per creare accumuli di libri che la maggior parte di noi non legge e non leggerà mai se si voglia evitare un voltastomaco. Walter Benjamin ci dice che «Uno dei compiti principali dell’arte è sempre stato quello di creare esigenze che al momento non è in grado di soddisfare». E allora Marco Furia, poeta genovese (1952, con una dozzina di volumi pubblicati), ci prova col suo volume Tratteggi (Anterem Edizioni/Cierre Grafica, 2017), fedele a Italo Calvino di «in questa predilezione per le forme brevi non faccio che seguire la vera vocazione della letteratura italiana», citazione riportata in epigrafe nel volume, invece di accumulare parole e frasi inutilmente sovrabbondanti, toglie quanto più possibile il superfluo riducendo i suoi scritti, piccolissimi racconti, a quasi dei frammenti che tendono all’essenzialità del discorso che non si svolge mai in prima persona:
– «Procuratosi rettangolare biglietto indicante il numero corrispondente all’attesa posizione nella lista di attesa, poiché tutti i sedili erano occupati, rimase in piedi accanto a distinto individuo la cui borsa, parzialmente aperta, mostrava di contenere numerose buste».
Sembra la descrizione minuziosa di un’attesa in un ufficio postale odierno, dove le attese, anche lunghe, sono una routine ormai. Questo è il linguaggio usato da Furia, descrittivo e minuzioso che tende a diminuire il vuoto tra la scrittura e il campo semantico, fino a rischiare la ripetitività dei suoni e dei ritmi, consapevole del fatto che un linguaggio racchiude in sé comunque un’impotenza a comunicare ciò che possiamo solo pensare. E allora perché arrovellarsi per accumuli che non garantiscono la sorpresa, il meraviglioso, l’inquietudine di una realtà? Non è meglio farsi condurre da un’automatica constatazione di ciò che vogliamo realizzare anziché da quello che riusciamo solo a pensare? E cosa constata la scrittura frammentaria e “automatica” di Furia?
Sembra che Furia sia nemico della scrittura. Invece attraverso piccole storie (quasi dei micro-racconti) di vita reale e quotidiana ripristina le azioni anziché le intenzioni, storie di realtà che denunciano l’impostura dei sentimenti, attraverso rumori, spazi, cose della vita. Per esempio guardare un passerotto saltellare attorno ad un tavolino di un bar alla ricerca di qualche briciola da beccare sotto gli occhi indifferenti di un cameriere che in completa trasgressione di un cartello con la scritta “si prega di non distribuire cibo ai volatili”.
Insomma piccole cose come una specie di servizio sociale come il richiamare, per es., l’attenzione dell’ufficio tecnico – immaginiamo della propria città – sulla pericolosità di un tombino uscito dalla sua sede. Storia di tutti i giorni, di una vita senza grosse aspettative ma non per questo senza importanza, narrata in terza persona, senza personaggi né nomi di persone, né protagonisti avvinghiati da una trama. Frammenti di vita, azioni di vita apparentemente banali ma quasi maniacali nella descrizione, come a p. 16:
– «Avendo notato come tondo bottone fosse sul punto di staccarsi, tentò di filo che ancora tratteneva l’utile dischetto: poiché la manovra non si mostrò agevole, estrasse taglienti forbici da cilindrica scatola e, inseriti pollice e indice della mano destra negli appositi anelli, perfezionò, con un sol colpo, la necessaria operazione».
 Allo stesso tempo è un’incitazione a non indietreggiare di fronte alle problematiche, questo lavoro di Furia, a non subire passivamente le azioni ma, testardamente, provocare una via d’uscita. Azioni descrittive ma minuziose, frammentate dal necessario e dalla necessità del momento, anche per allontanare illusioni e sentimenti fuorvianti. Azioni che si subiscono in piena coscienza fino ad arrivare a strappare un sorriso:
Allo stesso tempo è un’incitazione a non indietreggiare di fronte alle problematiche, questo lavoro di Furia, a non subire passivamente le azioni ma, testardamente, provocare una via d’uscita. Azioni descrittive ma minuziose, frammentate dal necessario e dalla necessità del momento, anche per allontanare illusioni e sentimenti fuorvianti. Azioni che si subiscono in piena coscienza fino ad arrivare a strappare un sorriso:
– «Domestico felino, in mattutina, solitaria, sosta sul bordo di ampio marciapiede, avrebbe rispettato il codice della strada?» (p. 18).
Quindi, per concludere si tratta di un volume che toglie il superfluo, l’enfasi della narrazione, e questo scopo dell’autore si realizza attraverso piccoli lacerti di racconti dove la frammentazione del linguaggio, appunto, sia pure didascalica e descrittiva, allontana quello che è presente nella narrativa, e che possiamo definire “illusoria consolazione”. D’altronde per Wittgenstein «Il linguaggio è un labirinto di strade, vieni da una parte e ti sai orientare, giungi allo stesso punto da un’altra parte e non ti raccapezzi più». Ancora Wittgenstein: «Per poter essere in grado di porre un limite al pensiero, dovremmo trovare entrambi gli estremi del limite pensabile (cioè dovremmo essere in grado di pensare quello che non può essere pensato)». Perché fingere con se stessi e con il lettore, ci sembra dire Furia, perché divorare i pensieri con l’illusione di possederli?:
– «Raggiunto policromo tappeto, messa in funzione l’elettrica scopa, fu sorpreso dall’automatico spegnimento della stessa: una lucente spia segnalava la necessaria (improrogabile) sostituzione del (ricolmo) sacchetto interno…».