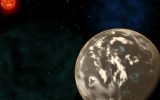La poesia di Marina Pizzi, nata a Roma nel 1955 dove vive, possiamo dire che si dipana su una unica traiettoria: l’inconscio, inteso come sogno, come allegoria, tra un caos interiore che cerca di ricucire gli strappi creati dal vivere quotidiano per portarsi verso quello che possiamo definire “ricompattazione delle cose”, appunto, frazionate o addirittura sgretolate da una società che tende a rendere tutto merce, materiali scontati da cui trarre comunque un vantaggio economico. Un lavorio lacerante per qualcosa di diverso rispetto a un linguaggio apodittico, pacifico, troppo permissivo. È il dramma di quei poeti che lavorano per uno “scarto dalla norma” che si slega dal vissuto a protezione di un sostrato costruttivo che denuncia l’inganno: in pratica la riscossa dei “numeri zero”, dei “disadattati”.
Poeta di un certo spessore, dal 1986, con Il giornale dell’esule (1986), sono già una dozzina i volumi pubblicati: Gli angioli patrioti (1988), Acquerugiole (1990), “Darsene il respiro” (1993), La devozione di stare (1994), Le arsure (2004), L’acciuga della sera i fuochi della tara (2006), Dallo stesso altrove (2008), L’inchino del predone (2009), Il solicello del Basto (2010), Ricette del sottopiatto (2011), Un gerundio di Venia (2012), La giostra della lingua il suolo d’algebra (2012), anche se ha iniziato a scrivere nel 1978 per un obbligo accademico, nel segno di Dante, di Montale e di Beppe Salvia, suo compagno di vita.
Ora si ripresenta con Plettro di compieta. Novantanove poesie 2008-2014 (Lietocolle, 2015), suddiviso in quattro parti. C’è un atto di opposizione al senso con automatismi del significante in regime di contraddizione in questa poesia “disarticolata” di Pizzi «nella rovina del girasole migrato | dentro le asole vili della roccia». È un proliferare al limite di un’allegoria delle cose, della realtà, un’accennata ironia ma in più punti abbastanza percettibile, una preghiera laica fatta di contrari nella blasfemia del dato della favola di una società protettrice dell’individuo che gioca barando sullo stato di salute del quotidiano ormai in coma profondo: «tutta la vita al calvario del senso | il verbo della bora a metterti all’erta | dal bordo del dolore con l’acredine | di stabilire un’orda di crepuscolo | dal corrimano che ti porta via | verso la retta del saliscendi | continuo al nuovo un nome di vendetta» (Plettro di compieta, p. 77).
Tra profilassi dell’inutile dire di una lingua che ha perso la sua spinta in avanti, e una giostra di inganni, la poesia di Pizzi, che sembra apparentemente pessimista (lutto morte noia agonia vuoto inedia, sono vocaboli che ricorrono spesso in questi testi) forte di un albore e di una speranza di vita novella nei confronti di una protervia del quotidiano, pur «nel martirio di reggersi in piedi | la tirata d’orecchi dei benpensanti | le pene in gergo | la stagione indigena | genuflessa all’altare del suo giro. | pennacchi d’ascia la scia della fronte | quando la pena lascia una sapienza | tanto inutile tanto» (id., p. 36).
Siamo quasi al limite di una catastrofe annunciata («… ho visto finire il tempo | in acque spremute per remi | senza fiotto. le piante grasse | sgonfiarsi per un eccesso | di tiro alla fionda, un dado nano | munirsi del mondo intiero…»), feroci attacchi alla natura, alla dignità dell’uomo contro cui – sembra farci capire Pizzi – la poesia è inerme, giacente nel limbo dell’attesa, «… dove l’alunno è un nome di gesso | dove il lungomare si addice al pregresso…, p. 81».
Ogni testo conserva al suo interno un quid d’irriducibilità, una funzione diacronica e zigzagante tra le sponde della norma con fulminee accelerazioni di matrice quasi neoromantica (la natura e il mondo animale è uno degli argomenti di queste poesie, e concorrono spesso alla citazione di un mondo migliore). Esplicativa è la tendenza a “significare” una impossibilità, a tradurre i segni del vivere interiore delle cose, del mondo e ricominciare «… chiamami nella pece dell’arrivo | nella rovina del girasole migrato | dentro le asole vili della roccia. | sorella partigiana sia girare | verso le giare delle giostre guaste | che spingono le gole a cicalare | polvere, p. 26».
Finzione, gioco, pathos, ironia, rovesciamento del senso allontanano dal campo una poesia autobiografica, come è di moda oggi. I testi diventato “corpo” e “voce” di una scenografia portata al grado zero, per un’allegoria del “nuovo”, di una speranza di scrittura conflittuale e contraddittoria.
La poesia pizziana nasce dalla poesia, tesa tra un corpus materico e tracce oniriche, rivendica un allargamento interpretativo di un autré ogni qualvolta il sentimento del tempo, di un cambiamento, assume i connotati dello scontato, per vie sotterranee allo scenario di una globalizzazione e pacificazione della poesia: «dallo scoglio è stato curato l’antro | velenoso di scompiglio, tu adesso | ne entri ne esci con agio di pargolo | ma solo ieri il gorgo era di palude | e senza gomiti il buono di appoggiarsi | alle manciate del ludo di trovare | finalmente il varo della foce…» (id., p. 97). Ha dichiarato in un’intervista, a cura di Ennio Abate (in «Poliscritture.it», 16 marzo 2015): «la mia scrittura si è elaborata nel tempo, le raccolte sono discontinue, oggi molto più fluide ma non logiche: scrivo per disperazione, oggi e ieri ma non all’inizio. in gioventù c’era un po’ di gioia, oggi il buio attivo. ormai chiedo solo di scrivere anche sulle sabbie mobili». In fondo la poesia non può fare altro che tentare di rendere possibile l’impossibile.